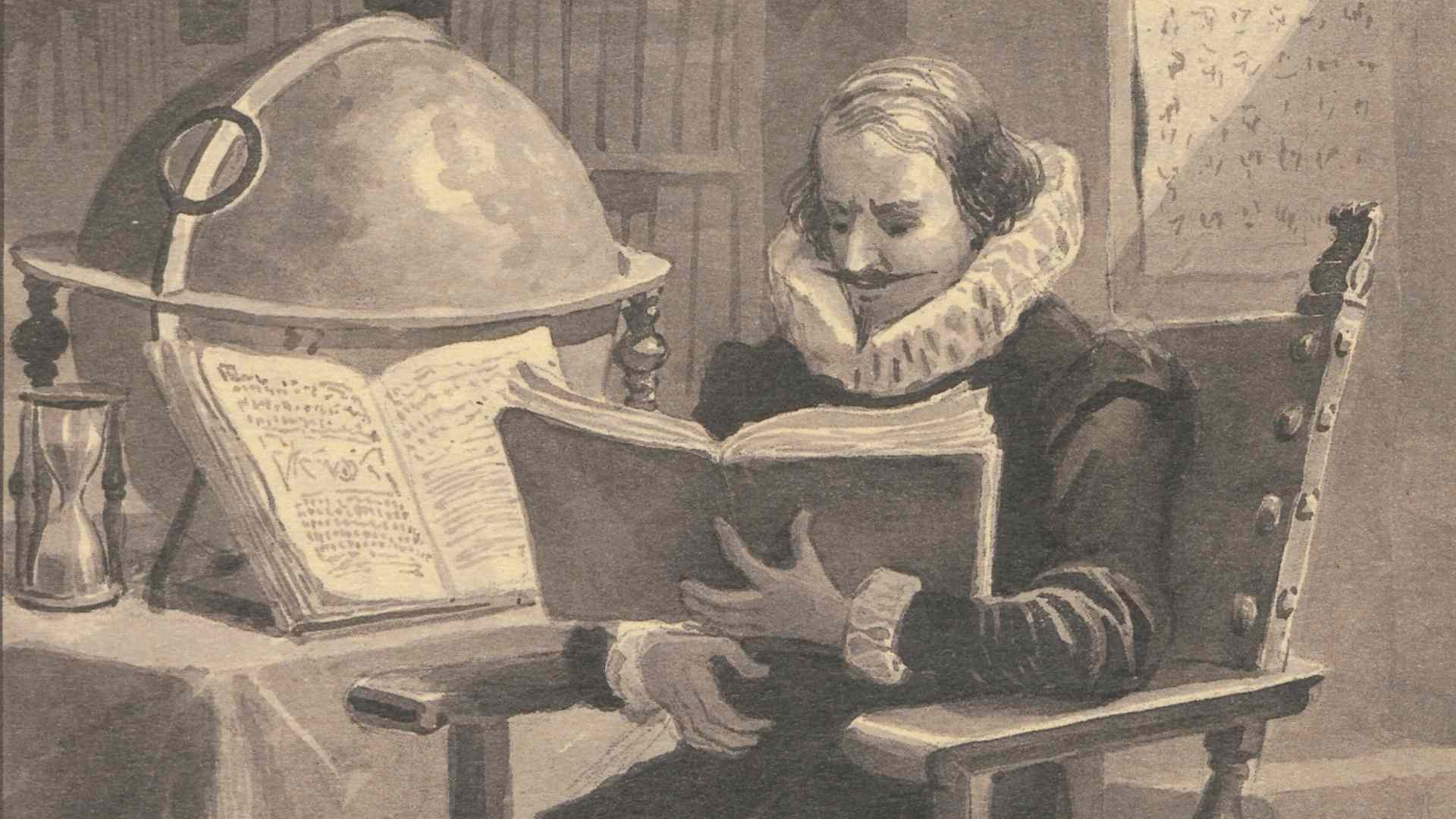25 Aprile: l’ideologia si è mangiata la memoria e la piazza è diventata tribunale

Il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, è da sempre una ricorrenza simbolica e fondativa della Repubblica italiana. Ma quanto accaduto quest’anno in diverse città – da Milano a Roma, da Torino a Trieste – impone una riflessione più profonda: a chi appartiene oggi l’antifascismo? E, soprattutto, chi ne stabilisce i confini?
Il paradosso milanese: la Brigata ebraica costretta a ritirarsi
A Milano, la Brigata ebraica ha dovuto abbandonare il corteo “per motivi di sicurezza”. Non un semplice incidente, ma il segno di una deriva ideologica. I discendenti di chi nel 1945 lottò contro il nazifascismo sono stati bersagliati da insulti (“assassini”, “Netanyahu terrorista”) da parte di chi, sventolando bandiere palestinesi, ha trasformato il corteo in un’arena geopolitica.
Se è servito l’intervento di polizia e volontari per contenere il confronto, non si è trattato di una normale contestazione. L’antifascismo perde la sua universalità quando diventa una clava ideologica: chi non si allinea viene marginalizzato, anche se portatore di una memoria autentica e storicamente fondata.
Roma e la frattura generazionale
Anche a Roma, le tensioni sono esplose. Studenti e sigle antagoniste hanno contestato l’Anpi, accusandola di essere “guerrafondaia” per le sue posizioni atlantiste e la vicinanza al Partito Democratico. Gli insulti, gli spintoni e la bruciatura di una bandiera della NATO hanno segnato la rottura.
Il corteo si è spaccato: da una parte i “padri” dell’antifascismo istituzionale, dall’altra una nuova generazione che vuole più processare che commemorare. È uno scontro tra memorie: tra chi vuole custodire il passato e chi pretende di riscriverlo. Il rischio? Che il 25 aprile diventi sempre più un evento divisivo anziché un momento di coesione.
Scontri a Torino e Trieste: quando la piazza perde il senso
A Torino e Trieste il clima è degenerato in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. L’antifascismo, invece di unirsi nella condanna delle violenze del passato, è finito risucchiato in una spirale di tensione permanente. Non più celebrazione della libertà, ma conflitto politico fine a sé stesso.
Antifascismo selettivo e zone d’esclusione
Preoccupa la trasformazione dell’antifascismo in una dottrina selettiva, che distingue tra “buoni” e “cattivi” sulla base delle posizioni su guerre contemporanee, Israele o l’Ucraina. Così facendo, si costruisce una nuova ortodossia che rifiuta il pluralismo e cancella il valore di chi, ottant’anni fa, ha combattuto per la libertà.
Difendere la memoria dalla semplificazione
Per rimanere un valore fondativo, l’antifascismo dev’essere inclusivo, non settario. Deve distinguere tra storia e attualità, tra memoria condivisa e divergenze legittime. Se diventa strumento di esclusione e polarizzazione, perde la sua funzione di patrimonio comune e diventa indistinguibile dal male che professa di combattere.
In un’epoca di revisionismi e disinformazione, è urgente recuperare un linguaggio che unisca verità storica, rispetto reciproco e responsabilità civile. Il 25 aprile deve tornare a essere una festa di libertà, non una resa dei conti ideologica.
Un invito al dialogo, non alla purga
Chi decide oggi chi può definirsi antifascista? È una domanda scomoda, ma necessaria. Se a prevalere sarà “chi grida più forte”, il rischio è chiaro: si passerà dalla liberazione alla purga, dalla memoria alla militanza escludente.
È tempo di invertire la rotta: solo un antifascismo pluralista e coerente può dare ancora senso a una delle date più importanti della nostra storia repubblicana. Chi usa l’antifascismo per costruire nuove esclusioni tradisce lo spirito stesso del 25 aprile. La memoria non è un’arma da brandire contro l’avversario di turno, ma un dovere civile che impone rispetto, verità e pluralismo. La libertà non appartiene a una fazione: appartiene a chi ha il coraggio di difenderla ogni giorno, senza riscrivere la storia a proprio uso e consumo.