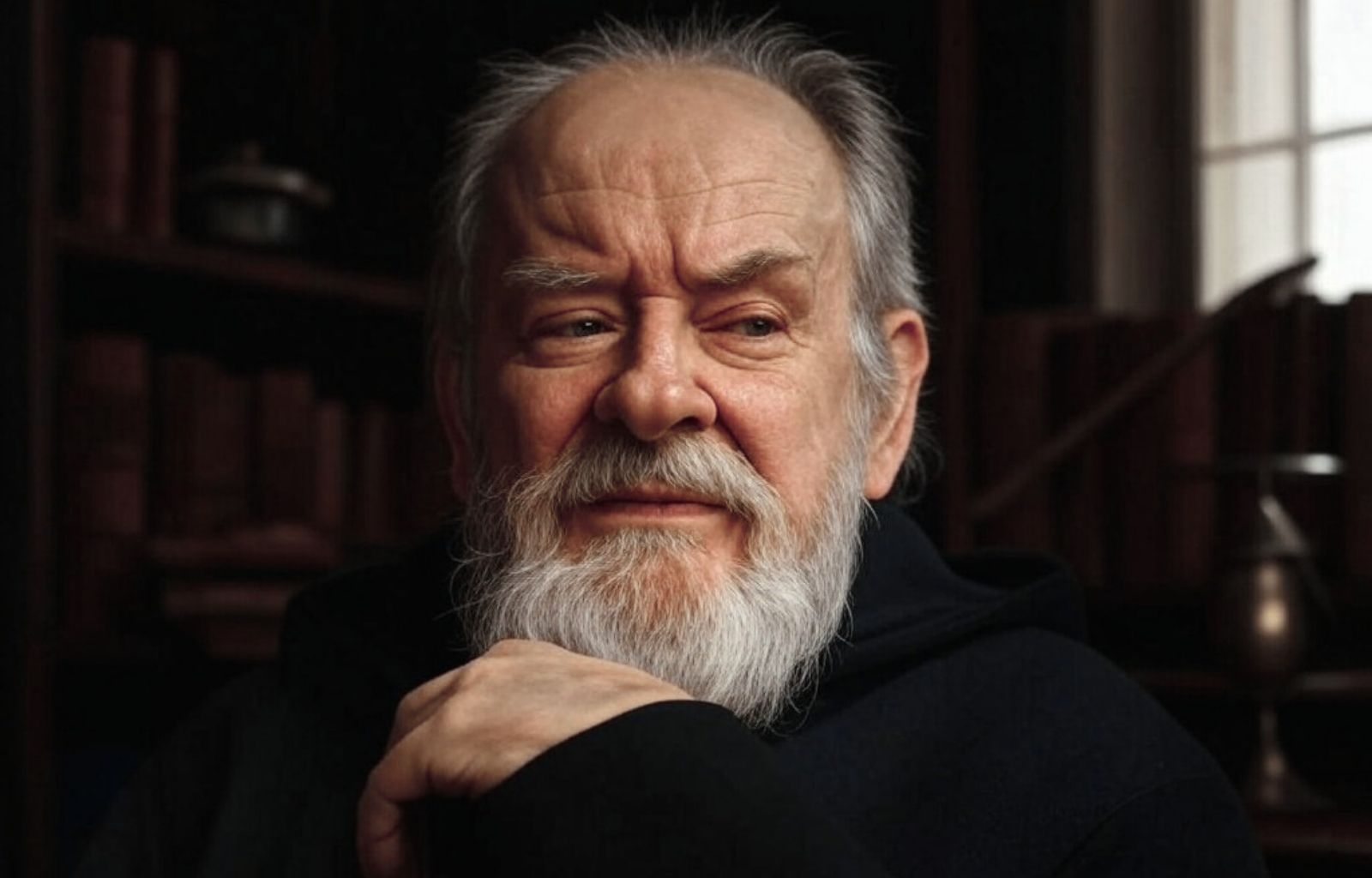Su Gaza Trump spariglia, bluffa e rilancia, ma qualcosa bolle in pentola

L’uscita di Donald Trump sul “transfer/relocation” dei palestinesi di Gaza riporta alla mente alcuni episodi non troppo lontani, avvenuti tra gennaio e agosto 2020. Questi fatti, all’epoca poco considerati, acquisiscono oggi nuovi significati, soprattutto se riletti alla luce delle dinamiche di normalizzazione tra Israele e alcuni Paesi arabi, e ci aiutano a decodificare (o almeno a provare) le dichiarazioni roboanti del presidente degli Stati Uniti durante la recente conferenza stampa tenutasi a Washington, in occasione della visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Il “Deal of the Century” e i suoi antecedenti
Il 28 gennaio 2020, dalla Casa Bianca, Trump annunciò al mondo – con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu al suo fianco – il cosiddetto “Deal of the Century”. Era la declinazione geopolitica del piano “Pace per prosperità”, avviato in Bahrein nel giugno 2019 nell’indifferenza generale. Questo contesto fu anche la fase in cui vennero gettate le basi per gli Accordi di Abramo, uno scenario in cui il lavoro dietro le quinte si è sempre rivelato cruciale per i grandi eventi del Medio Oriente (guerra del Kippur, visita di Sadat in Israele, attacco del 7 ottobre 2023, e così via).
La proposta di Trump prevedeva una sua personale interpretazione del principio “due popoli, due Stati”, con il mantenimento della maggior parte degli insediamenti israeliani e scambi territoriali minimi rispetto ai precedenti negoziati (Oslo, Camp David, Annapolis). La capitale palestinese sarebbe stata spostata ancora più a Est, verso Abu Dis, e Gaza sarebbe stata ripensata in ottica di sviluppo turistico (una vera e propria “riviera di Gaza”). La reazione internazionale fu di scherno e respingimento, molto simile a quanto accade oggi di fronte alla recente “bomba” di Trump su Gaza.

La mappa concettuale della proposta di Trump del gennaio 2020
La prospettiva dell’annessione
Poco dopo, iniziarono a circolare voci su un possibile passo verso l’annessione – o estensione della sovranità israeliana – sulle Aree C dei Territori Palestinesi. La stampa indicava un via libera da parte di Trump, interpretando alcune dichiarazioni dell’allora ambasciatore americano in Israele, David Friedman. Da tempo, gli Stati Uniti avevano già spostato la loro ambasciata a Gerusalemme, senza che fosse scoppiato un conflitto globale.
All’epoca, Netanyahu annunciò che avrebbe proceduto all’annessione dal 1° luglio 2020, ma in realtà non avvenne nulla di concreto. Ogni dichiarazione rimaneva nel limbo, complicata anche dalle problematiche interne alla coalizione di governo (c’era la rotazione con Benny Gantz) e dai freni posti dalla stessa amministrazione Trump. In pratica, tutto sembrava un enorme bluff, mentre evidentemente dietro le quinte si stava preparando qualcos’altro.

Yousef Al Otaiba e il segnale degli Emirati
Il 12 giugno 2020 accadde un fatto rilevante: Yousef Al Otaiba, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington, firmò un editoriale in ebraico sul quotidiano israeliano Yediot Ahronot, dal titolo “Annessione o normalizzazione”. Era la prima volta che, in modo così diretto, emergevano pubblicamente i negoziati sotterranei tra Israele e alcuni Paesi arabi. Arrivò il 1° luglio e non successe nulla; né il 2, né il 3, né il 4. La tanto annunciata annessione rimase lettera morta.
Gli Accordi di Abramo
Il 13 agosto 2020, verso le ore 18 in Israele, Trump annunciò via Twitter:
“HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!”
Fu così che il mondo venne a conoscenza degli Accordi di Abramo, ai quali aderirono in seguito anche Bahrein, Marocco e Sudan (quest’ultimo congelò poi la propria adesione a causa della rinnovata guerra civile).
La consecutio risulta evidente: Trump lanciò (o apparentemente appoggiò) due “proposte scandalose” – il “Deal of the Century” e l’annessione – che non si concretizzarono, ma aprirono la strada alla normalizzazione tra Israele ed Emirati. Quel primo passo rappresentava l’inizio di un progetto ben più vasto, in cui l’Arabia Saudita è rimasta più defilata, forse per testare la reazione dell’opinione pubblica. Un progetto che l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 mirava anche a far deragliare, ma che non sembra esser stato realmente interrotto.
L’Arabia Saudita e i segnali di una normalizzazione in corso
Uno dei segnali più concreti dello stato avanzato di questa normalizzazione è legato al traffico aereo. Dopo il 7 ottobre 2023, molte compagnie internazionali hanno sospeso i voli verso Israele. Eppure, l’unica destinazione rimasta regolarmente operativa dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è Dubai, con numerosi voli quotidiani.
Ciò non solo ha sostituito in parte l’hub di Istanbul (la Turchia ha comunque intenzione di riprendere le tratte verso l’estate), ma soprattutto evidenzia un dato fondamentale: questi voli sorvolano l’Arabia Saudita, che ha concesso a Israele lo spazio aereo fin dal settembre 2020. Riducendo drasticamente la durata dei voli, Riad ha manifestato nei fatti una propensione a mantenere aperto un canale di dialogo, benché non ufficializzato a livello politico.
Cosa c’entra tutto questo con la “bomba” di Trump su Gaza?
Non esiste una risposta univoca, ma la sensazione è la stessa del 2020: qualcosa bolle in pentola.
Una possibile chiave di lettura è che Trump stia alzando l’asticella per fare pressione sui Paesi arabi, usando la minaccia di un coinvolgimento diretto nella questione palestinese come “arma del giorno del giudizio”. Nelle sue dichiarazioni ha detto che “gli USA possederanno Gaza” e che a pagare dovranno essere “i ricchi Paesi circostanti di buon cuore”. Una proposta palesemente irrealistica – “è mia, ma paghi tu” – di cui Trump stesso è perfettamente consapevole.
Dunque, forse lo scopo è dichiarare pubblicamente il progetto di trasferimento (transfer/relocation) e mettere in luce l’ipocrisia dei governi arabi, che per 76 anni hanno mantenuto i palestinesi in campi profughi senza cittadinanza (Libano, Siria), o come cittadini discriminati (Giordania), o hanno rifiutato di averli sul proprio territorio (Egitto, che nei suoi Accordi di Camp David non volle riprendersi anche Gaza insieme al Sinai). Una mossa che potrebbe spingere i Paesi arabi a dire “no” al transfer, ma a concedere un “sì” su qualcos’altro.
Il possibile “sì” da strappare
L’annuncio di Trump è stato rilasciato il 4 febbraio, vale a dire il 16° giorno dall’inizio della tregua tra Israele e Hamas, quando dovrebbero partire le trattative per la seconda fase dell’accordo, quella che dovrebbe condurre al rilascio degli altri 64 ostaggi ancora nelle mani di Hamas e a un cessate il fuoco definitivo.
I “sì” cui Trump punta potrebbero quindi riguardare un impegno più incisivo da parte dei Paesi arabi (specialmente l’Arabia Saudita) affinché, con la fine delle ostilità, Hamas non abbia più alcun ruolo né amministrativo né politico a Gaza. Come misurare questa “resa” di Hamas? Una delle ipotesi, anche se piuttosto fantasiosa, potrebbe essere un rilascio totale degli ostaggi in tempi certi – tre mesi, ad esempio – senza la strategia di rilascio centellinato negli anni. Se ciò non bastasse, Trump ha già annunciato la possibilità di esprimersi tra quattro settimane sul sostegno a un’eventuale annessione delle Aree C. Un meccanismo di pressione molto simile a quello del 2020.
Uno scenario in evoluzione
Questo ovviamente non esclude che l’idea scandalosa del trasferimento/ricollocazione possa trovare, in futuro, una sua applicazione, anche solo parziale, magari con l’apertura illimitata dei confini e incentivi per chi volesse emigrare (si parla di possibili centinaia di migliaia di persone, a seconda degli stimoli economici).
Un aspetto fondamentale, quando si cerca di interpretare Trump, è che in genere non parla a caso: se dice di averne discusso con Egitto, Giordania e Arabia Saudita, e perfino se questi Paesi smentiscono, lui sa che il loro impegno effettivo verso la causa palestinese è meno forte di quanto proclamino in pubblico. Di fatto, sta facendo loro un vero e proprio outing. E qui sorge un problema: nella cultura araba, rivelare pubblicamente trattative segrete è un potenziale “dealbreaker”. Gli accordi importanti si tessono dietro le quinte e lì dovrebbero rimanere finché non maturano le condizioni per annunciarli. Il team negoziale di Trump, che conosce bene tale cultura, non può ignorarlo.
Tutto ciò rafforza la sensazione che, ancora una volta, qualcosa stia davvero bollendo in pentola.