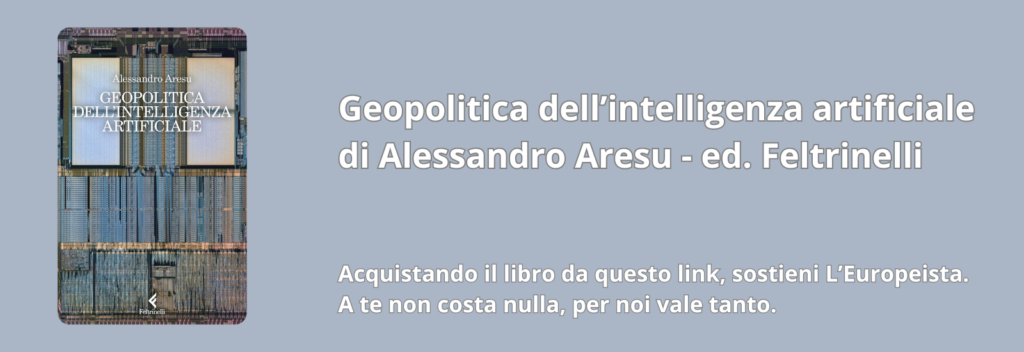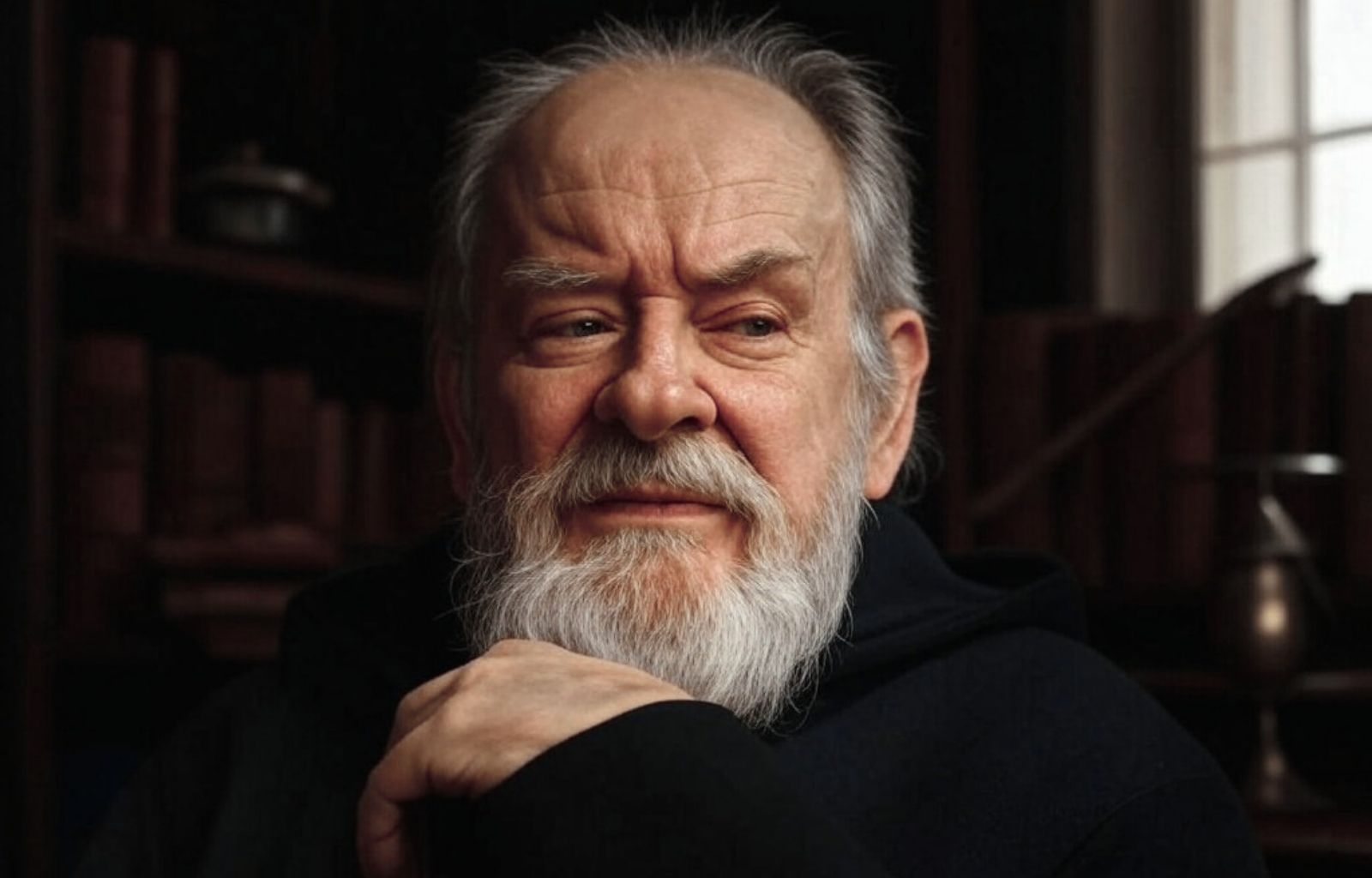Il 20 per cento della PAC all’intelligenza artificiale: una proposta

L’intelligenza artificiale si sta imponendo come la tecnologia più dirompente e strategica del nostro tempo, apportando trasformazioni irreversibili a settori chiave quali sanità, difesa, finanza e istruzione, per citarne alcuni. Se possiamo considerare questa affermazione come un dato acquisito, allo stesso modo, mentre Stati Uniti e Cina stanno continuando a investire massicciamente nello sviluppo e nell’applicazione dell’IA, consolidando il loro primato tecnologico, è evidente come l’Unione Europea ha adottato finora un approccio prevalentemente normativo.
Un orientamento che, pur avendo il merito di affrontare le sfide etiche e regolatorie legate all’IA, ha alimentato dubbi e riflessioni sulla capacità dell’Europa di competere sulla frontiera tecnologica e nei campi che periodicamente ridefiniscono gli equilibri economici globali. Se ne sta parlando ormai in modo sempre più consapevole, perché la sfida non è solo tecnologica, ma geopolitica: senza una strategia e un piano di investimenti mirato, il rischio è che l’UE rimanga sempre di più relegata a un ruolo marginale, dipendente dalle innovazioni sviluppate altrove.
UE e IA, tra regolamentazione e ritardo competitivo
L’UE è stata la prima al mondo a introdurre un quadro normativo dedicato all’AI, con l’AI Act, un regolamento volto a garantire un utilizzo sicuro e trasparente delle tecnologie intelligenti. L’approccio europeo si basa su una classificazione dei rischi associati all’IA, ponendo severe limitazioni sui sistemi considerati ad alto rischio, come quelli utilizzati per la sorveglianza biometrica o per la gestione di servizi pubblici.
Sebbene pionieristica in termini di tutela dei diritti e della sicurezza, tale regolamentazione ha suscitato critiche crescenti all’interno del dibattito pubblico e tra gli operatori del settore. Il timore principale – condivisile, oltre che legittimo – è che l’Europa, si sia autoimposta vincoli che freneranno lo sviluppo di applicativi IA Made in Europe, altamente strategici nella competizione globale.
I dati confermano un divario già marcato, destinato a crescere sic stantibus rebus: secondo El País, solo il 7% degli investimenti mondiali in software e applicazioni digitali proviene dall’Europa, mentre gli Stati Uniti ne raccolgono il 71% e la Cina il 15%. Questa sproporzione riflette un ritardo strutturale nell’ecosistema tecnologico europeo, dovuto a una combinazione di fattori: scarsa integrazione del mercato digitale, frammentazione delle politiche industriali e un’insufficiente capacità di attrarre o investire capitali adeguati in ricerca e sviluppo.
Eppure – controversie su furti e distillazioni di modelli a parte – basti pensare al recente sviluppo del modello di intelligenza artificiale DeepSeek-V3, realizzato in Cina con un budget irrisorio di appena 5,6 milioni di dollari, ha dimostrato come il mercato dell’AI potrebbe non essere così saturo come sembrava e che è ancor possibile creare realtà competitive capaci di sfidare i grandi colossi tecnologici anche in Europa, se solo l’UE riuscisse a riequilibrare gli sforzi tra l’attitudine a regolamentare e a incentivare l’innovazione.
Un cambio di passo da Bruxelles e Parigi
Per fortuna, gli ultimi annunci provenienti dall’Unione Europea e dalla Francia sembrano voler rispondere proprio alle critiche sulla mancanza di investimenti. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato la creazione di un fondo da 20 miliardi di euro per promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo dell’IA, con l’obiettivo di mobilitare complessivamente 200 miliardi di euro e costruire quattro “giga-stabilimenti” dedicati. Pochi giorni dopo, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato la volontà di attrarre 500 miliardi di investimenti entro i prossimi quattro anni, puntando su costi energetici contenuti (grazie all’energia nucleare) e sulla formazione di 100.000 professionisti all’anno. Questi annunci segnano un parziale cambio di rotta rispetto all’approccio puramente normativo: un tentativo di ridurre il divario con Stati Uniti e Cina, colmando le lacune in termini di risorse e infrastrutture. Basti pensare che, di recente, anche attori completamente europei, come la startup Mistral IA, hanno iniziato a mostrare il potenziale del Vecchio Continente con modelli open-source di nuova generazione. Se tali iniziative produrranno effetti tangibili, l’UE potrebbe finalmente affiancare alla regolamentazione un vero piano industriale per l’IA, riallineando la propria programmazione finanziaria e, soprattutto, puntando a una sovranità tecnologica più solida.
Una proposta: l’uso della programmazione dei fondi europei
Ovviamente, al di là delle intenzioni e degli annunci, le risorse poi vanno concretamente mobilitate, e questo non è affatto semplice. Proviamo dunque a sviluppare una riflessione e una proposta. L’Unione Europea ha storicamente utilizzato la programmazione dei Fondi Europei come strumento per promuovere investimenti e sviluppo, con l’obiettivo di ridurre le disparità economiche tra le regioni e rafforzare la competitività dei suoi Stati membri, finanziando infrastrutture, innovazione, ricerca e coesione sociale e destinando risorse significative a settori strategici.
Il bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027, insieme allo strumento temporaneo per la ripresa NextGenerationEU, ammonta a circa 2.018 miliardi di euro. Questo bilancio è suddiviso in diverse categorie di spesa, ciascuna destinata a specifici settori di intervento: una distribuzione che riflette le priorità strategiche dell’UE che non considera settori emergenti come l’intelligenza artificiale.
Chiaramente vi sono dei limiti intrinsechi, come l’impostazione settennale della programmazione, un orizzonte temporale fino troppo lungo considerando che la competizione nei settori altamente tecnologici viaggia a una velocità esponenzialmente più elevata, o la mancata previsione di meccanismi di flessibilità nell’allocazione delle risorse per rispondere alle nuove sfide tecnologiche. Probabilmente vi è anche una certa difficoltà nel ricalibrare la programmazione per ragioni di “spesa storica” o, in altre parole, per le incrostazioni causate dal peso delle lobby e di controverserendite di posizione (vedi proteste dei contadini).
378 miliardi di euro per la PAC
Un esempio evidente è rappresentato dalla Politica Agricola Comune (PAC), che continua ad assorbire una parte significativa delle risorse europee. Istituita nel 1962, la PAC è una delle politiche più longeve dell’UE e ha rappresentato per decenni uno dei pilastri fondamentali dell’integrazione europea. Nata in un contesto post-bellico, la PAC rispondeva a esigenze quali garantire la sicurezza alimentare in un’Europa che ancora portava le cicatrici della Seconda Guerra Mondiale, aumentare la produzione agricola per evitare carestie e dipendenza dall’esteroe stabilizzare i mercati e garantire un reddito equo agli agricoltori europei.
Nel corso degli anni, la PAC è stata riformata per adeguarsi alle nuove sfide, introducendo misure per la sostenibilità ambientale e la modernizzazione del settore agricolo. Ancora oggi la sua centralità nel bilancio dell’UE resta una costante, nonostante la trasformazione economica del continente e i già consistenti investimenti realizzati. Per il periodo 2021-2027, la PAC dispone di una dotazione finanziaria di 378 miliardi di euro, una quota di bilancio superiore a quella destinata all’innovazione e al digitale.
L’allocazione storica di risorse alla PAC è il risultato di equilibri politici consolidati: il settore agricolo ha sempre avuto un forte peso nei negoziati tra Stati membri, e Paesi con una grande tradizione agricola – come Francia e Italia – hanno da sempre difeso il mantenimento di finanziamenti consistenti. Logiche che ancora oggi producono una ripartizione delle risorse europee non più sostenibile e funzionale alla competizione globale paradossalmente anche per lo stesso settore agrifood che, come sostenuto da una folta letteratura, beneficerebbe notevolmente in termini di sostenibilità delle produzioni e qualità dei prodotti proprio da una massiccia applicazione di tecnologia e intelligenza artificiale.
Probabilmente, se l’UE volesse rafforzare la propria competitività nel XXI secolo, potrebbe iniziare proprio interrogandosi sulla programmazione delle risorse. In altre parole, anche considerando che tutti i settori economici del Vecchio Continente, compresa l’agricoltura, beneficerebbero indirettamente dallo sviluppo applicativo dell’IA, ha ancora senso destinare quasi 400 miliardi alla PAC quando l’IA riceverà appena qualche spicciolo?
AAA big tech cercasi
Altra criticità europea è l’assenza di player in grado di sostenere la competizione con le big tech americane e asiatiche. L’Europa, nonostante la sua forza economica e industriale, non è mai riuscita a dare vita a colossi digitali come le statunitensi Google, Amazon, Microsoft, Apple e Meta da un lato, e le cinesi Alibaba, Tencent e Baidu dall’altro. Queste compagnie dominano il panorama tecnologico globale, lasciando l’UE in una posizione marginale. Come suggerisce il recente caso legato al possibile ingresso di Starlink quale fornitore tecnologico dell’Italia, il risultato è una dipendenza strutturale dalle piattaforme digitali straniere, con implicazioni dirette sulla sovranità tecnologica, la gestione dei dati e la sicurezza economica.

L’assenza di Big Tech europee non è casuale, ma il risultato di decenni di scelte politiche ed economiche che hanno privilegiato altri settori, lasciando il digitale nelle mani di attori extraeuropei, ma soprattutto che hanno considerando prematuramente perse alcune sfide tecnologico-industriali, come sta avvenendo proprio con l’intelligenza artificiale. Mentre negli Stati Uniti e in Cina l’innovazione è stata favorita attraverso ingenti investimenti pubblici e un ecosistema normativo flessibile, l’Europa ha adottato un approccio conservativo e illusoriamente difensivo, concentrandosi sulla regolamentazione e sulla tutela del mercato unico piuttosto che sullo sviluppo.
L’UE è stata pioniera nel regolamentare il digitale, imponendo limiti alle grandi piattaforme e cercando di contrastarne lo strapotere con misure come il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA). Ma a differenza degli Stati Uniti, dove le grandi aziende tecnologiche sono nate da un forte sostegno governativo – basti pensare al ruolo della DARPA nello sviluppo di internet e della Silicon Valley – e della Cina, che ha adottato un modello di sovranità digitale, l’Europa ha lasciato lo sviluppo del settore quasi esclusivamente alle iniziative private, senza una vera strategia industriale comune né una visione che attribuisse alle infrastrutture digitali un valore strategico di qualche tipo.
Cosa fare
L’Europa non ha avuto il suo Google, il suo Facebook o il suo Alibaba, ma le sfide dell’intelligenza artificiale e dei computer quantici – a titolo esemplificativo – potrebbero rappresentare un’opportunità per non ripetere gli stessi errori. Il rischio è che anche queste rivoluzioni tecnologiche vengano dominate da Stati Uniti e Cina, lasciando l’Europa ancora una volta in una posizione di dipendenza tecnologica e di conseguente sudditanza geopolitica.
Non è sarebbe dunque solo una questione economica, ma di sovranità e di libertà, in un mondo che vede di fatto superati gli equilibri sanciti dal Patto Atlantico e in cui chi controlla la tecnologia controlla i dati, le infrastrutture e l’economia.
Se l’Europa volesse colmare il divario digitale, sarebbe necessario un radicale cambio di rotta e ciò richiederebbe investimenti significativi e mirati. Un’opzione concreta potrebbe essere quella di rivedere la programmazione europea, rimpinguando o rimodulando il bilancio europeo. Ad esempio, se anche solo il 20% della PAC fosse riallocato all’IA, l’Europa potrebbe disporre di più di 75 miliardi di euro per varare un Piano Europeo per l’Intelligenza Artificiale, in grado di stimolare la nascita di campioni tecnologici europei.
Ma non è solo questione di risorse: servono un cambio di paradigma e una visione che favoriscano la crescita delle imprese digitali, incentivino la ricerca applicata e creino un contesto normativo non soffocante. In ballo ci sono l’indipendenza tecnologica, la sicurezza e la libertà dei cittadini europei. La sfida è aperta, ma ancora per poco.