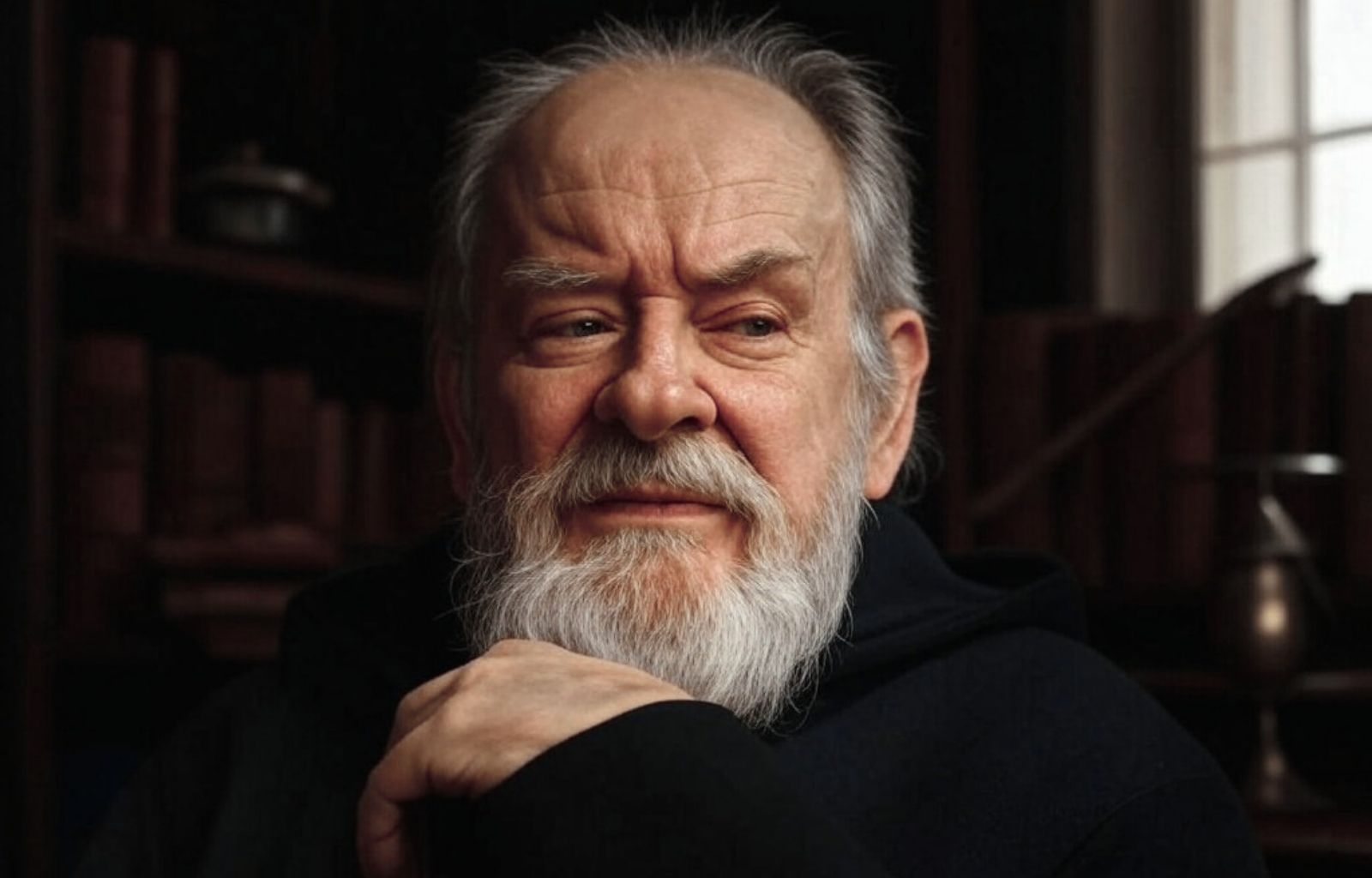A Parigi si riunisce l’Europa che serve, oltre l’attuale UE

Parigi, 17 febbraio 2025. Mentre un gruppo ristretto di Paesi europei e rappresentanti istituzionali si riunisce per discutere la crisi ucraina e i rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump, torna alla memoria un episodio di vent’anni fa: la paura degli “idraulici polacchi” agitata in Francia durante il referendum del 2005. Quell’immagine fu uno degli spauracchi che contribuì a far bocciare la Costituzione Europea, bloccando un processo di integrazione più profondo. Ironia della sorte, proprio la Polonia siede oggi al vertice di Parigi come uno dei Paesi più risoluti nel difendere la stabilità del Vecchio Continente.
Se la Costituzione Europea fosse stata approvata allora, forse oggi l’Unione Europea sarebbe più pronta, agile e rapida nell’affrontare le sfide geopolitiche. Ma la storia non concede appelli e così, oggi, al vertice convocato dal presidente della Repubblica Francese non si riunisce l’Unione Europea (se non attraverso i suoi rappresentanti istituzionali presenti all’incontro), ma l’Europa che serve, o per meglio dire l’Europa che può: Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Danimarca, oltre al segretario generale della Nato Mark Rutte e appunto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
Quest’ultimo aveva ricevuto la sollecitazione di diversi capi di governi della UE perché convocasse un vertice straordinario del Consiglio UE, ma dopo un rapido giro di consultazioni è giunto alla conclusione che la mossa sarebbe stata controproducente, perché avrebbe offerto un assist al putiniano Viktor Orban e mostrato l’impotenza dell’architettura istituzionale UE ad agire efficacemente. La formula intergovernativa di Parigi, con l’impegno assunto da Emmanuel Macron a tener dentro i rappresentanti delle istituzioni comunitarie, è parsa anche a Costa la soluzione più opportuna.
Per Trump, la vera terra rara da sfruttare è la frantumazione del blocco commerciale UE
Il vertice segna l’inizio di un’era, quella di un’Europa che ha scoperto (ma lo sapevamo ormai da tempo) di non poter più vivere nell’ombra della protezione americana, quello scudo transatlantico che è stato il presupposto stesso dell’integrazione economica del Vecchio Continente dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.
Le parole pronunciate mercoledì dal segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, il discorso di JD Vance a Monaco e l’annuncio di negoziati prima segreti e ormai pubblici tra Trump e Putin hanno reso chiaro che gli Stati Uniti non intendono più farsi carico della sicurezza europea e, con l’attuale Amministrazione, intendono approfittarsi addirittura della fragilità politica europea per smantellare finanche il blocco economico e commerciale. In Ucraina, l’Amministrazione Trump non vede solo l’opportunità di accaparrarsi concessioni per lo sfruttamento delle terre rare, ma anche di ribaltare proprio vantaggio i rapporti commerciali con l’Europa, rispetto ai quali l’esistenza di una “cosa” chiamata Unione Europea rappresenta ormai per Washington (come peraltro per Mosca, che da anni foraggia politici e media a tal scopo) un ostacolo irritante.
Di fronte a questa nuova realtà, proprio l’architettura della UE, con i suoi vincoli istituzionali, la sua lentezza decisionale e i veti incrociati, si dimostra inadatta a rispondere alla crisi. Nulla che noi europeisti non sapessimo e denunciassimo da anni, almeno da quando quel referendum francese decretò una frenata brusca del processo di integrazione, lasciando la neonata unione monetaria priva di un cruciale bilanciamento politico.
Per questo, a Parigi, oggi non si riunisce l’Unione Europea, ma l’Europa che conta e che può concretamente permettere a questo meraviglioso continente di proteggere il suo spazio civile dalla plurima aggressione esterna. Eppure, c’è ancora spazio per una speranza e per l’ottimismo. Rebus sic stantibus, il summit di Parigi può l’inizio di un processo. Come accadde nel 1790 in America, quando il presidente Alexander Hamilton colse l’opportunità della crisi del debito per trasformare una confederazione di Stati in una vera unione federale, così oggi gli europei potrebbero sfruttare la crisi transatlantica per accelerare la creazione di un pilastro europeo della difesa, dentro o fuori il recinto UE. La domanda è se i leader europei avranno il coraggio di cogliere questo momento hamiltoniano o se si lasceranno paralizzare dalle divisioni interne e dai colpi violenti che arrivano dall’esterno.
Che vi sia una sempre maggiore consapevolezza, è ormai evidente. Come evidenziano gli autori del Mattinale Europeo, la Polonia è l’esempio più emblematico della portata dello shock europeo. Mercoledì, Donald Tusk dichiarava che “Ucraina, Europa e Stati Uniti devono essere completamente uniti”. Sabato, la sua posizione era già cambiata: “L’Europa ha urgente bisogno di un suo piano d’azione sull’Ucraina e sulla nostra sicurezza”. Un riposizionamento impensabile fino a pochi giorni fa.
La fine dell’illusione Brexit e l’esitazione tedesca
Se la frammentazione dell’UE è un segnale di debolezza, la presenza di Keir Starmer al tavolo di Parigi è invece una dimostrazione di pragmatismo. Dopo anni di tensioni post-Brexit, il Regno Unito si ritrova a cooperare strettamente con i governi europei. Non per ideologia, ma per necessità: Londra ha compreso che la sua sicurezza dipende direttamente dalla stabilità dell’Europa continentale.
L’annuncio del governo britannico sulla disponibilità a inviare truppe in Ucraina per garantire la sicurezza in caso di un cessate il fuoco mostra quanto la geopolitica abbia ormai travolto le illusioni sovraniste di isolamento.
L’assenza di una linea chiara da parte della Germania è la principale incognita del summit. Berlino ha il peso economico per fare la differenza, ma ha sempre esitato nel trasformare la sua influenza in leadership geopolitica. Olaf Scholz è chiamato a un salto di qualità: se la Germania continuerà a restare impantanata nei suoi dubbi, il processo di autonomia strategica dell’Europa si svilupperà senza di essa.
Evitare un nuovo 1938
Le parole di Volodymyr Zelensky alla Conferenza di Monaco sono state un avvertimento: la Russia sta preparando 150.000 soldati in Bielorussia, pronti a colpire il fianco orientale dell’UE. Se Berlino non è pronta a reagire ora, quando lo sarà? Come nel 1938, l’Europa si trova di fronte alla scelta tra la resistenza e la resa. “Monaco mai più”, ha dichiarato Tusk. È questa la posta in gioco del vertice di Parigi. Se i leader europei non riusciranno a definire una strategia chiara, l’Europa rischia di rimanere spettatrice di un negoziato tra Trump e Putin che ridefinirà l’ordine globale senza di lei. Ma se Parigi sarà il punto di partenza per una nuova architettura di sicurezza europea, allora potremmo davvero essere davanti al nostro momento hamiltoniano. Un’Europa capace di difendersi da sola non è più un’opzione teorica. È una necessità.
Un esercito europeo: dall’utopia alla necessità
Il vertice di Parigi potrebbe dunque essere il punto di partenza per un passo storico: la creazione di una forza di difesa comune europea. Fino a oggi, l’idea di un esercito europeo è rimasta confinata nelle dichiarazioni politiche e in progetti di cooperazione limitati. Ma con il ritiro degli Stati Uniti, l’Europa non può più permettersi di rimandare.
L’UE ha già strumenti finanziari che potrebbero essere mobilitati rapidamente. Il Meccanismo Europeo di Stabilità, creato per la crisi del debito, potrebbe essere riadattato per fornire finanziamenti d’emergenza alla difesa. Ursula von der Leyen ha annunciato che le regole del Patto di Stabilità verranno sospese per permettere investimenti nella sicurezza, come già avvenne durante la pandemia.
Ma i finanziamenti non bastano. Serve una chiara volontà politica. E qui, la questione centrale è se gli Stati europei siano pronti a impegnarsi direttamente sul campo. Macron spinge per l’invio di truppe in Ucraina, Starmer si è già detto disponibile, ma la Germania e l’Italia restano più caute.
Verso una nuova politica industriale ed energetica europea
Oltre alla dimensione militare, la crisi ha reso evidente la necessità di un riassetto delle relazioni economiche. Come dicevamo, la guerra commerciale che l’Amministrazione Trump ha iniziato contro l’Europa non si limiterà all’Ucraina. Il “de-risking” pensato per la Cina potrebbe dover essere applicato anche agli Stati Uniti.
Il rafforzamento dell’industria della difesa europea diventa dunque una priorità. La Commissione ha annunciato un Libro Bianco a marzo per delineare le strategie industriali e tecnologiche necessarie per garantire l’autosufficienza strategica. Ma questo sforzo non può essere limitato alle istituzioni europee: anche i governi nazionali dovranno allineare le loro politiche a questo obiettivo, adottando misure coerenti per rafforzare la capacità produttiva e la competitività del continente.
Un’Europa più forte militarmente deve essere anche un’Europa più forte economicamente. La crescita e l’innovazione industriale sono le vere leve per ridurre la dipendenza dalle importazioni strategiche e rendere il continente un centro di eccellenza tecnologica. In questo quadro, la sicurezza energetica non è solo una questione di resilienza geopolitica, ma un prerequisito per lo sviluppo economico. La guerra in Ucraina ha dimostrato quanto la volatilità dei mercati energetici possa impattare la competitività delle imprese e la stabilità dei sistemi produttivi europei.
La Germania e l’Italia continuano a pagare il prezzo della rinuncia al nucleare, una scelta che oggi appare come una zavorra per la crescita industriale. Berlino, dopo aver spento le sue ultime centrali nel 2023, ha dovuto compensare con importazioni costose, mentre Roma resta frenata da un referendum che ha bloccato lo sviluppo dell’energia atomica, lasciando il paese dipendente da fonti meno stabili e più onerose. Se l’Europa vuole accelerare la propria crescita economica e sostenere l’industria del futuro, non può permettersi di escludere il nucleare dalla propria strategia energetica.
Parigi può essere la nostra Philadelphia, o una seconda Waterloo
Alla fine, la storia non aspetta: o l’Europa saprà rispondere a questa crisi con una vera unione politica e militare, o lascerà che siano altri a decidere le sorti del nostro continente. Polonia, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, tutti i protagonisti della complessa vicenda europea sono oggi chiamati a scrivere il prossimo capitolo di un racconto che potrebbe segnare la fine dell’illusione di vivere nell’ombra altrui. Parigi, in questo senso, potrebbe essere ricordata come la nostra Philadelphia: se avremo il coraggio di varare una difesa comune e un nuovo patto politico, allora l’Europa potrà finalmente diventare adulta e compiere quel salto di qualità che l’incompiuta Costituzione europea aveva sognato. Se non sarà così, se sulle ambizioni comuni prevarranno gli interessi particolari, Parigi sarà una Waterloo.