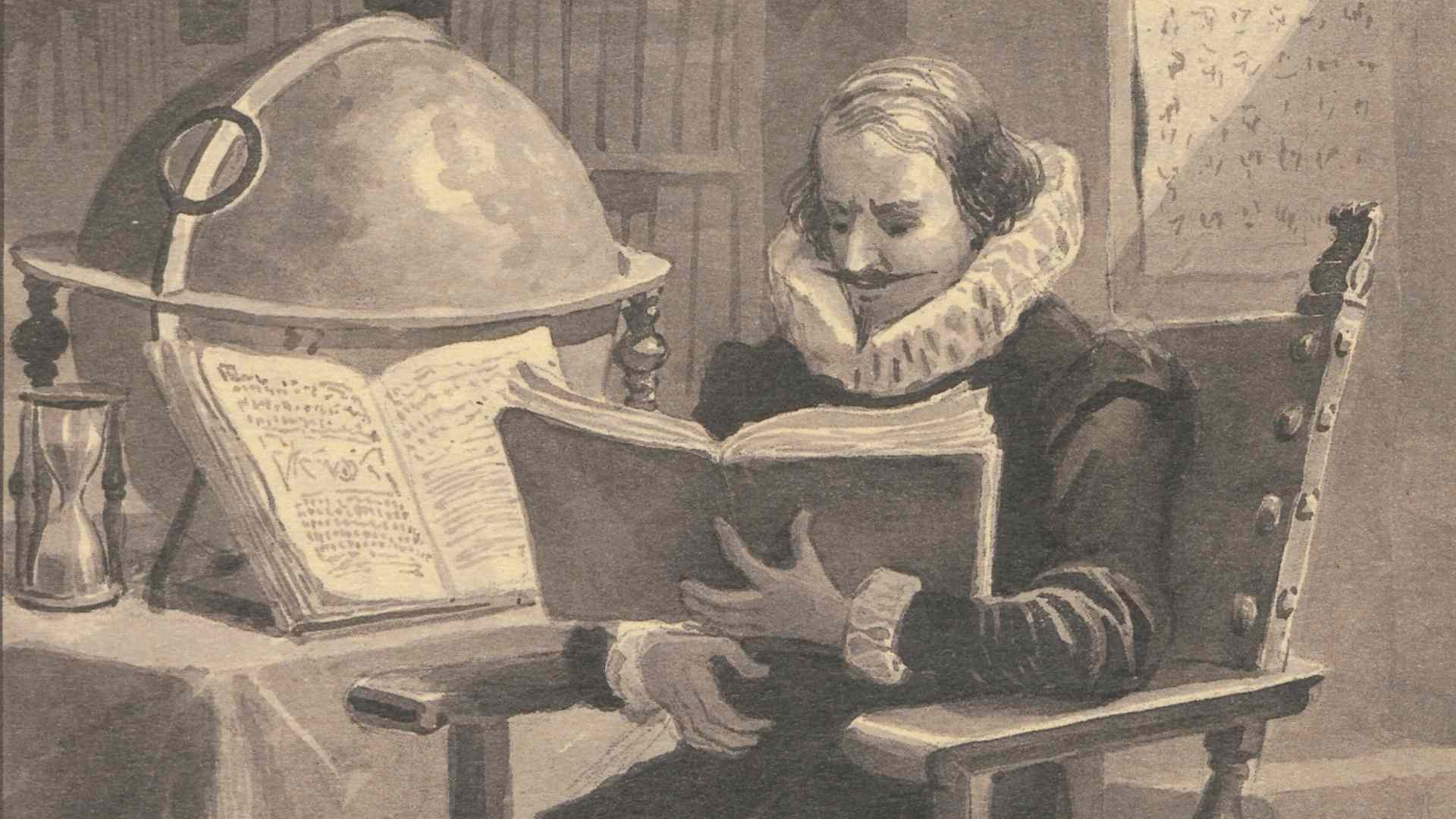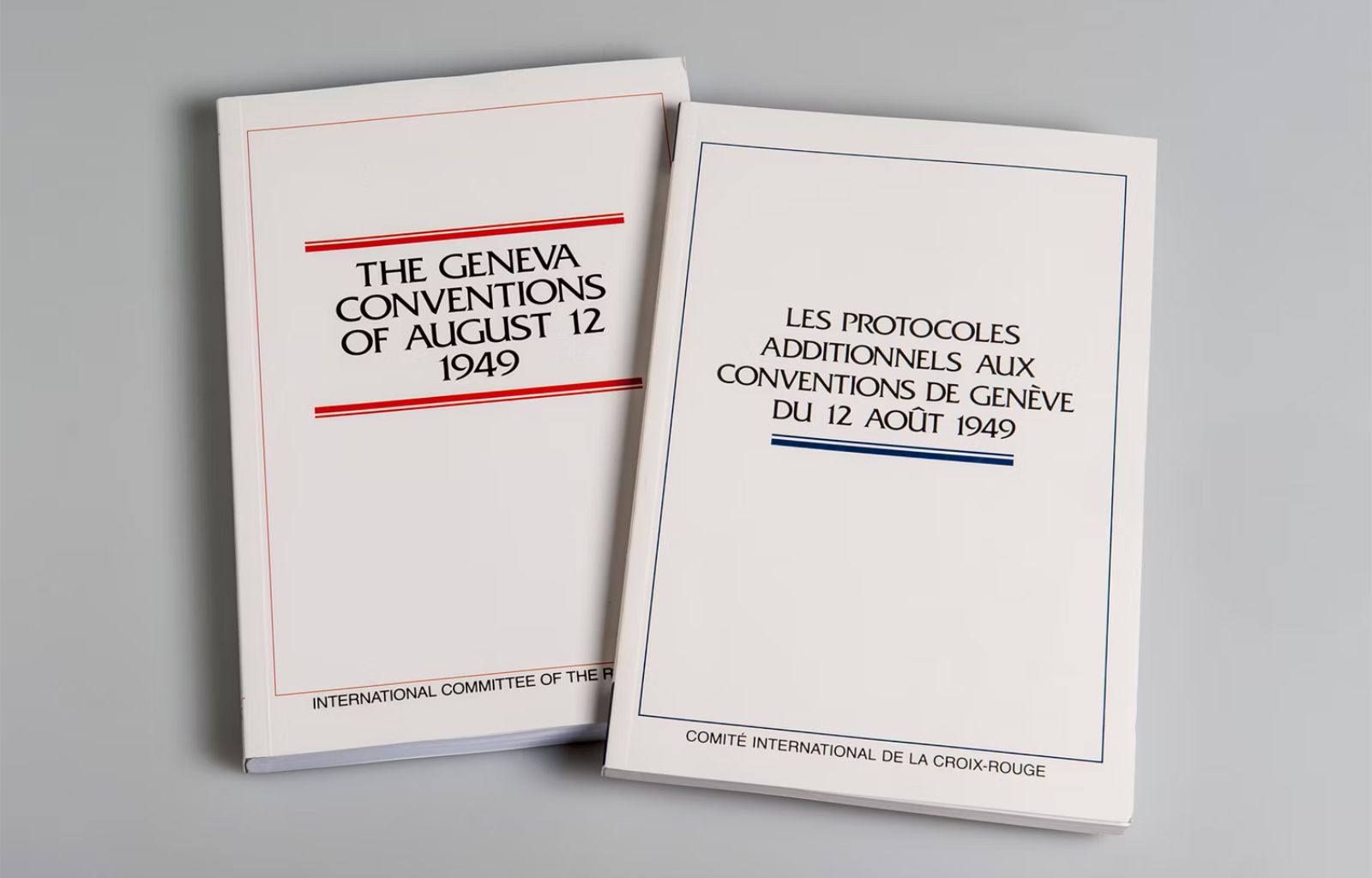Francesco, tra compassione e contraddizione

Con la morte di Papa Francesco, si chiude una stagione peculiare del cattolicesimo contemporaneo. Il primo pontefice latinoamericano della storia, gesuita e argentino, ha rappresentato una frattura netta rispetto ai suoi predecessori europei, non tanto per la sua provenienza geografica… ma per la visione del mondo che dall’America Latina ha portato con sé a Roma.
Un Papa populista?
Per comprendere davvero il pontificato di Francesco, bisogna infatti partire proprio dalla “fine del mondo”. Come ha scritto lo storico Loris Zanatta, Bergoglio è incomprensibile senza il peronismo, e dunque senza quella visione del mondo in cui religione, politica e popolo si fondono in una narrazione millenaristica, apocalittica, salvifica. Un populismo morale e spirituale più che ideologico, che ha visto nel popolo – soprattutto nel popolo povero e devoto – il luogo privilegiato della verità, e nelle élite la fonte della corruzione.
Scrive Zanatta: «La parabola di ogni populismo è la sua: c’era una volta un popolo puro, forgiato dall’evangelizzazione, ma un’élite lo tradì, lo sottomise, lo contaminò. Finché un redentore, un caudillo popolare e religioso, lo redime per condurlo alla terra promessa». In questa logica, tipica di una certa cristianità sudamericana, Francesco ha interpretato il suo ruolo pontificio più come missione profetica che come custodia della tradizione.
Un’Europa rimproverata, ma mai dimenticata
L’Europa, nelle parole di Francesco, è apparsa una civiltà vecchia, stanca, ammalata di egoismo e consumismo. Ha denunciato i suoi muri, la sua paura dello straniero, il suo individualismo sterile. Ma non l’ha mai completamente abbandonata: l’ha visitata, ha parlato ai suoi parlamenti, ha lanciato appelli ai suoi giovani. L’ha spronata a ritrovare l’anima, non a rivendicare il potere. Tuttavia, il tono è stato spesso quello del profeta che ammonisce, più che del pastore che accompagna.
In ciò, Francesco ha rotto con la tradizione eurocentrica del papato: il suo sguardo è stato globale, spesso terzomondista, esplicitamente antioccidentale. Ha elogiato la saggezza delle culture religiose asiatiche, ha mostrato una certa indulgenza verso regimi autoritari purché comunitaristi, ha criticato l’egemonia culturale dell’Occidente liberale con toni talvolta caricaturali.
Nei frutti autentici dell’Illuminismo, valorizzati dal suo predecessore Benedetto XVI, egli ha invece intravisto il peccato originale dell’Occidente.
La guerra in Ucraina: condanna e diplomazia
La guerra in Ucraina è stata una delle prove più complesse del pontificato, ed è stata condotta con una certa ambiguità. Francesco ha condannato con parole nette l’invasione russa, parlando di una «guerra sacrilega», «disumana» e «una sciagura vergognosa per l’umanità». Ha inviato cardinali a portare aiuti nelle zone colpite e ha accolto giovani ucraini e ne ha lodato il coraggio. Tuttavia, la sua diplomazia ha scelto la via della neutralità attiva: Francesco ha sempre evitato di nominare direttamente Putin, ha mantenuto canali aperti con Mosca e ha persino criticato – in un’intervista del 2022 – l’“abbaiare della NATO alle porte della Russia”.
E quando nel 2024, parlando di negoziati, evocò il coraggio della “bandiera bianca”, suscitò una polemica feroce, provocando la necessità di chiarimenti successivi da parte della Santa Sede. Il suo sguardo, più teologico che geopolitico, ha messo al centro le vittime e il dolore umano, ma ha finito per lasciare interdetti coloro che avrebbero voluto dal papa una parola più netta in difesa della sovranità ucraina e contro il cinismo imperiale e imperialista del Cremlino.
Un progressismo ambiguo
Francesco è stato definito da molti “un papa progressista”. Ma in cosa è consistito il suo progressismo? Certamente nel tono inclusivo, nella volontà di aprire le porte della Chiesa a chi si era allontanato: divorziati, omosessuali, non credenti. Ma sul piano dottrinale, la rivoluzione è stata più annunciata che compiuta.
In questo senso, il suo rapporto con l’Europa secolarizzata è stato ambiguo: qui ha parlato da riformatore, altrove da difensore della tradizione.
Ha denunciato la “colonizzazione ideologica” dell’Occidente, ma ne ha usato il linguaggio per riconquistare i lontani.
Il risultato è stato un magistero fluido, comunicativamente potente ma spesso contraddittorio.
Critiche, ma non da destra
Sia chiaro: le nostre critiche non hanno nulla a che fare con quelle, rabbiose e ottuse, di una certa destra reazionaria che ha mal sopportato il papa aperto verso le persone LGBTQIA+, coraggioso nell’abbattere i muri e nel difendere i migranti. Se Francesco ha irritato quei mondi è perché ha parlato con la lingua del Vangelo più puro.
Ma nel suo pontificato si è avvertita anche la poca fiducia verso le libertà individuali, verso l’autonomia del pensiero laico, verso quel pluralismo democratico che rappresenta uno dei frutti più maturi della civiltà europea.
Il rischio non era il progressismo, ma un pauperismo paternalista, un moralismo antioccidentale incapace di distinguere le contraddizioni dal valore universale della libertà.
Cosa resterà?
Francesco ha certamente inciso nella nostra coscienza. L’ha provocata, ferita, stimolata. Il suo pontificato ha rispecchiato le tensioni del nostro tempo: tra Nord e Sud del mondo, tra popolo e istituzioni, tra fede e ragione, tra tradizione e modernità.
A qualcuno sembrerà che abbia fatto fare passi avanti alla Chiesa; ad altri, che l’abbia riportata a un antimodernismo spiritualista.
Il tempo dirà se il suo sarà stato un pontificato di transizione o di rottura.
Per noi europei, però, Francesco resterà il Papa venuto dalla fine del mondo che ci ha ricordato, con voce severa e accento argentino, che la fede non è un’eredità da difendere, ma una scelta da rinnovare.
E che il Vangelo, prima di essere dottrina, è compassione.