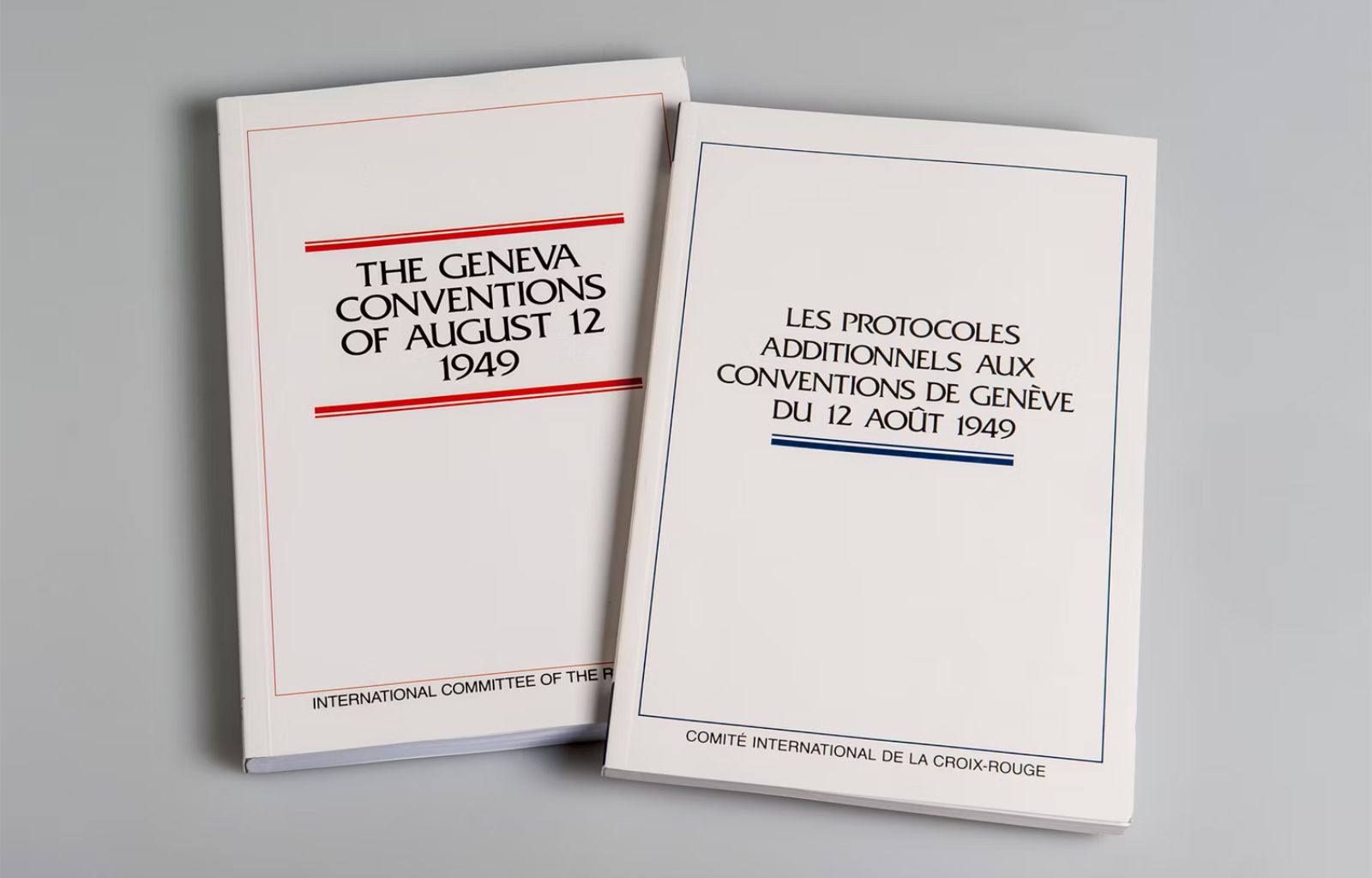Dopo Francesco: quale voce per l’Europa nel mondo?

Sovranismi, crisi valoriale e la diplomazia che manca
La morte di Papa Francesco non è solo un evento religioso: è una scossa geopolitica che si propaga
ben oltre le mura vaticane. Francesco ha incarnato una forma inedita di diplomazia: non fatta di eserciti o trattati, ma di simboli, empatia, dialogo. Mentre l’Europa perdeva centralità, il Papa si imponeva come voce morale globale. Ora, con la sua scomparsa, si apre un vuoto che Bruxelles
sembra impreparata a colmare. La domanda è semplice, ma spietata: l’Unione Europea è pronta ad
assumersi quel ruolo? (qui un nostro articolo che analizza la figura di Francesco)
L’Europa e il vuoto spirituale
Negli ultimi dieci anni, l’Unione Europea ha progressivamente disimparato a parlare di sé. Ha dimenticato il linguaggio della visione, della cultura, dell’identità. Si è lasciata schiacciare dalle scadenze contabili, dai regolamenti interni, dalle rendicontazioni semestrali che sostituiscono ogni
impulso ideale. In questa crisi di rappresentazione, il continente si è trincerato nella tecnica e ha
smesso di porsi la domanda più scomoda: chi siamo?
Questo vuoto di pensiero strategico ha prodotto un vuoto più grave: un vuoto spirituale. L’Europa ha rinunciato alla propria vocazione come potenza del senso, e ha abdicato al proprio ruolo nella costruzione di una narrazione mondiale. La geopolitica è rimasta nelle mani degli apparati.
La coscienza, invece, è stata esternalizzata. In questo scenario di delega e afasia, una voce si è alzata fuori dalle istituzioni europee, ma dentro la storia europea: quella di Papa Francesco.
Mentre Bruxelles parlava la lingua delle clausole sospensive, Francesco parlava a nome di chi non ha voce. Mentre il Consiglio Europeo produceva comunicati vaghi e blindati, il Papa visitava i campi profughi, dialogava con l’Islam, denunciava le guerre dimenticate. Non ha offerto soluzioni
tecniche, ma ha costruito una supplenza morale che ha colmato – almeno parzialmente – il vuoto di legittimità dell’Europa.
Un modello di leadership profondamente europeo
La sua “geopolitica della misericordia” non è mai stata neutrale. È stata alternativa. Francesco non
ha semplicemente fatto diplomazia: ha esercitato un potere controintuitivo, fondato sul simbolismo, sulla lentezza, sull’empatia. Ha scelto di non allinearsi, ma di posizionarsi. Di restare aperto a tutti, persino a coloro che l’Occidente dichiarava irredimibili. E in questo ha proposto un modello di leadership profondamente europeo, benché da tempo dimenticato: quello che unisce etica e politica.
Questa postura ha dato all’Europa – almeno a una parte di essa – una parvenza di anima.
Il Vaticano, con Francesco, è stato il luogo in cui si teneva in vita un’idea antica di Europa: quella
dell’incontro, della mediazione, della profondità. Un’Europa che non urla, ma ascolta. Che non controlla, ma accompagna. Che non impone, ma orienta. Tutto ciò, per paradosso, non veniva dalle istituzioni europee, ma da una Chiesa sempre più percepita come marginale. Eppure decisiva.
Con la morte di Francesco, questa supplenza si interrompe. E con essa si apre una fase di silenzio scomodo. Chi raccoglierà il testimone? Chi saprà parlare non solo ai governi, ma ai popoli? Non solo alle cancellerie, ma alle coscienze?
Il rischio è che, nel vuoto lasciato dalla voce papale, si rafforzino quelle più fragorose ma meno
significative. Le voci identitarie, reazionarie, apocalittiche. Le narrazioni che vendono sicurezza in cambio di libertà, semplificazioni in cambio di complessità, isolamento in cambio di coesione. La geopolitica della paura, in contrapposizione a quella della misericordia.
Una sfida per l’Europa: recuperare la propria funzione narrativa
È qui che si apre la vera sfida per l’Europa: tornare a essere interprete di un ordine simbolico, oltre che economico. Recuperare la propria funzione narrativa. Tornare a dire qualcosa di significativo al
mondo, senza aspettare che lo facciano altri. Senza rifugiarsi dietro la diplomazia anonima di un comunicato stampa. Senza cedere ogni volta il ruolo di testimone, di guida, di custode.
Perché ciò che la morte di Francesco ci consegna, al di là del lutto, è un’eredità scomoda. Non ci ha detto cosa pensare. Ci ha mostrato come pensare. Ha restituito dignità al silenzio, al dubbio, alla compassione. Ha ricordato che potere e coscienza non sono incompatibili.
Se l’Europa saprà ascoltare, non dovrà nemmeno imitare. Dovrà solo tornare a essere ciò che in fondo è sempre stata nei momenti migliori della sua storia: una forza spirituale prima ancora che
una forza politica. Una voce che sa ancora parlare al mondo, non perché ha più carri armati o più PIL, ma perché ha più idee. Più coraggio. Più profondità.
E se non lo farà, se continuerà a delegare la propria anima a voci esterne, allora il vero vuoto non sarà quello lasciato da Francesco, ma quello che noi stessi ci siamo costruiti.
L’Italia tra Vaticano e Bruxelles
L’Italia, da sempre al crocevia tra sacro e secolare, ha occupato una posizione strategica nella proiezione esterna della Chiesa. Il Vaticano, con la sua dimensione extraterritoriale, ha trasformato
Roma in una capitale morale e simbolica, nodo centrale della diplomazia multilaterale e dei processi di mediazione. Questa vicinanza fisica e culturale ha garantito all’Italia un ruolo privilegiato nei teatri internazionali, pur non sempre meritato dalla qualità della sua classe dirigente. Tuttavia, negli ultimi anni, questa rendita simbolica è andata progressivamente erodendosi.
L’ascesa delle forze sovraniste ha generato una narrazione politica dominata da istanze identitarie,
protezionistiche, in aperta antitesi con quella diplomazia morale che Francesco ha tentato di strutturare su scala globale. Se da un lato l’Italia ha continuato a ospitare il centro della cattolicità,
dall’altro ha smesso di incarnarne la vocazione: è mancata un’adesione autentica a quella visione del mondo che il Pontefice argentino ha cercato di trasmettere, fatta di diritti umani, giustizia sociale, cooperazione internazionale.
Il paradosso è evidente: mentre il Papa parlava alle periferie del pianeta, l’Italia si trincerava nelle proprie ansie di identità. Mentre Francesco incontrava i rifugiati, Roma siglava accordi di
contenimento con governi ambigui. Mentre il Pontefice denunciava le diseguaglianze globali, il dibattito politico italiano si riduceva alla contabilità del “prima gli italiani”. In questo scarto si
consuma l’ambiguità italiana: una nazione geograficamente centrale ma moralmente decentrata.
Con la morte di Papa Francesco, si chiude un’epoca in cui la Chiesa ha di fatto sopperito alle
carenze del sistema politico italiano in materia di credibilità esterna. Il Papa – uomo, pastore, leader
globale – ha spesso parlato laddove le istituzioni italiane tacevano. Ha rappresentato un’Italia
migliore: più visionaria, più coerente, più rispettata nel mondo. Ora che quella voce si è spenta, la
crisi non è solo ecclesiastica. È anche profondamente italiana. Si è smarrito un punto di riferimento che, pur non istituzionale, suppliva a un vuoto sempre più evidente.
Roma caput mundi
Oggi, Roma non è più la capitale morale d’Europa. È sede di potere, ma non di visione. È centro di negoziati, ma non di narrazioni. La fine del pontificato di Francesco segna la necessità, per l’Italia, di ridefinire il proprio ruolo nel contesto europeo e mediterraneo. Smettendo di vivere di rendita ritrovando, se possibile, un’autonomia progettuale e morale che non dipenda solo dall’eco
vaticana. In caso contrario, il Paese rischia di assistere, muto e disorientato, al tramonto della propria centralità, mentre altri – più coerenti, più credibili – prenderanno la parola.
L’occasione mancata (o ritrovata?)
La morte di Papa Francesco, per l’Unione Europea, può segnare un vuoto oppure spalancare una possibilità. Un’occasione irripetibile per tornare a pensarsi come potenza etica, non solo economica o normativa. Per anni, l’UE ha relegato temi come la promozione della pace, i diritti umani e la cooperazione internazionale al ruolo di “soft power decorativo”, buoni per i comunicati stampa, ma secondari nei tavoli veri del potere. Ora non basta più. La geografia del potere globale è mutata: siamo dentro un ordine multipolare dove le narrazioni valgono quanto – se non più – delle sanzioni. E chi non ha un racconto, non ha una direzione.
Ma l’Europa, oggi, fatica. Le sue istituzioni comuni sulla politica estera – dalla PESC al Servizio Europeo per l’Azione Esterna, passando per l’Alto Rappresentante – hanno difficoltà a trovare una voce realmente autonoma, autorevole e credibile. La funzione di Alto Rappresentante si è spesso ridotta a una diplomazia notarile, senza il carisma politico che servirebbe in un’epoca di crisi globali intrecciate.
La frammentazione degli interessi interni, l’unanimità come vincolo decisionale, la
lentezza nell’azione: tutto contribuisce a una debolezza strutturale che si traduce in irrilevanza.
Francesco aveva un racconto. Una “geopolitica della misericordia” capace di parlare a Sud e Nord,
Est e Ovest, con linguaggi diversi ma unificante. L’Europa può – e forse deve – ereditarne la grammatica diplomatica: meno vincoli burocratici, più credibilità valoriale. Non si tratta di sostituire il Vaticano, ma di riconoscere che coerenza, simbolismo e visione morale sono risorse strategiche, non idealismi da convegno.
L’Unione è ora chiamata a decidere se restare una potenza a metà o farsi architrave di un nuovo ordine globale centrato sulla dignità, la responsabilità, l’umano. Francesco ha indicato la strada.
Tocca all’Europa non lasciarla svanire nel vuoto.