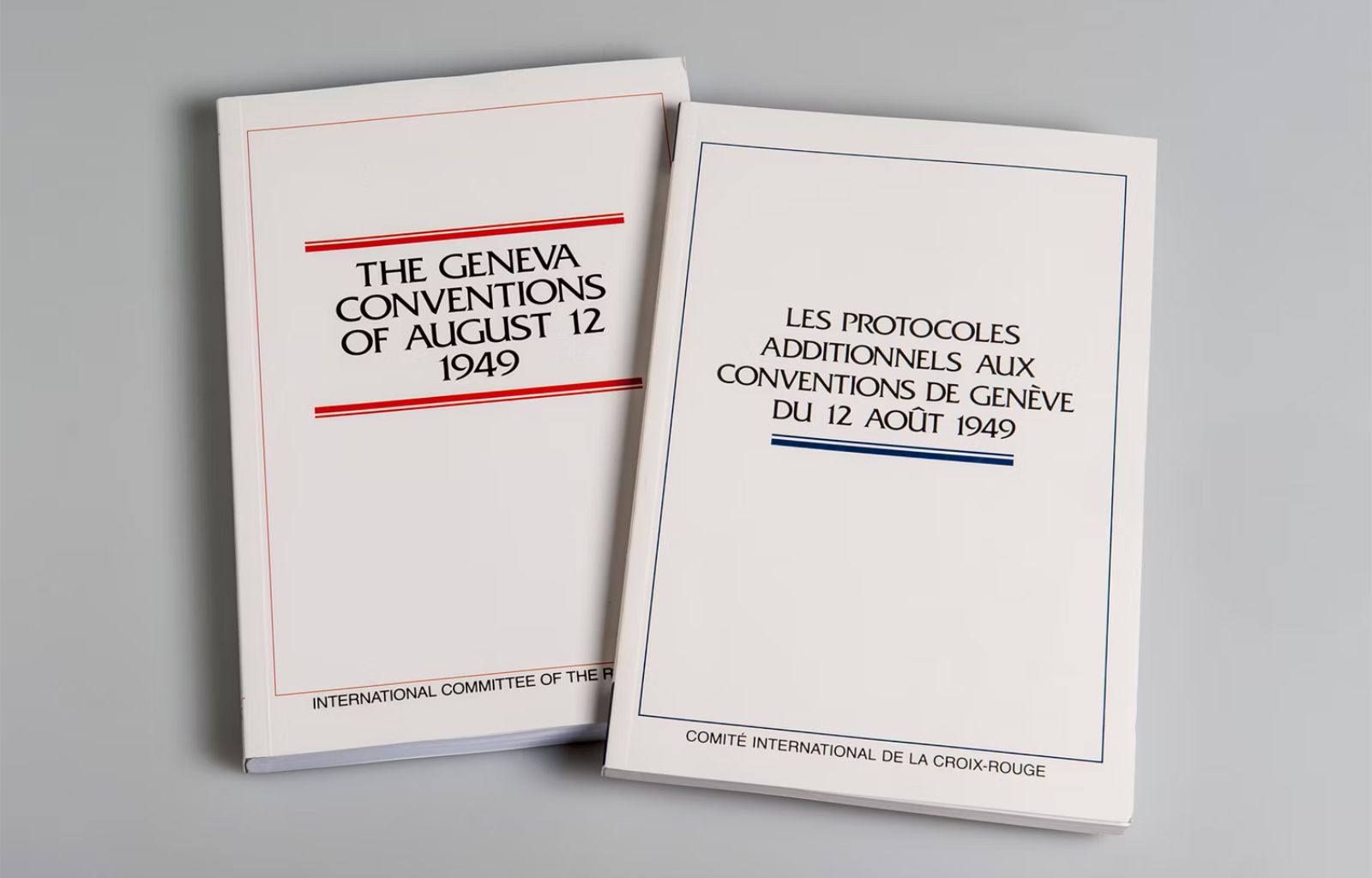Galileo, perché il mito piace più della storia vera?
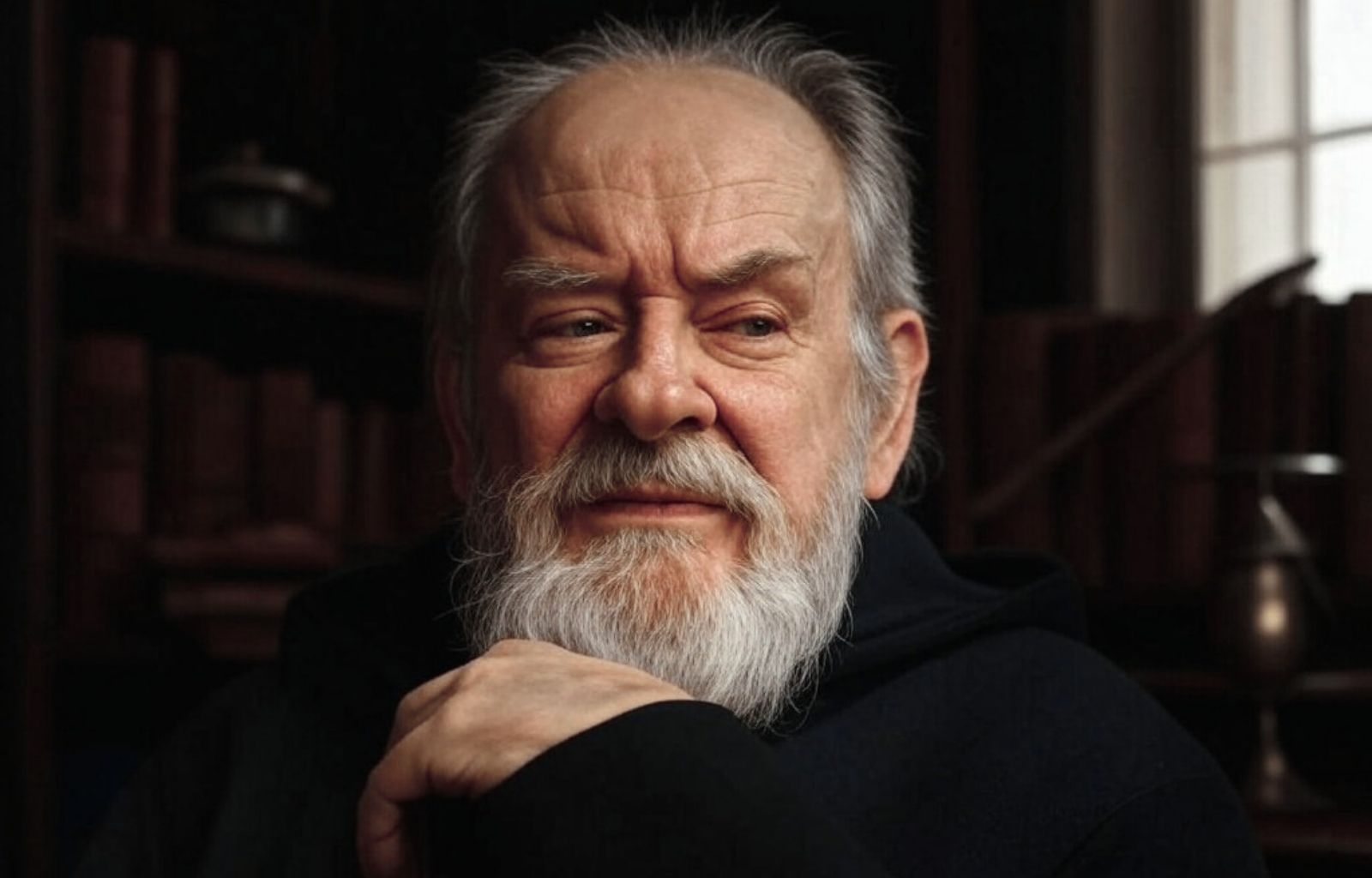
Se Galileo fosse nato in Lapponia, avrebbe fatto il pastore di renne e non il padre del metodo sperimentale, a dispetto di tutto il suo talento. Penso che su questo qualunque persona ragionevole sia d’accordo. Eppure, se facessimo il passo successivo, chiedendoci in che cosa la costellazione degli stati italiani che esisteva a cavallo del 1600 fosse più adatta a far nascere quel metodo rispetto alla Lapponia, le risposte apparirebbero sorprendenti agli occhi di molte persone ragionevoli.
Quali fattori, dunque, hanno permesso a Galileo di sviluppare il metodo sperimentale proprio in Italia? Potrebbero entrarci qualcosa le università, creazioni tipiche del Medioevo cristiano. In particolare quella di Padova, che ospitò Galileo nel periodo più fecondo dei suoi studi e del suo insegnamento, dove la ricerca era più libera che altrove grazie alla costituzione repubblicana di Venezia (un altro tipico rimasuglio del Medioevo).
Potrebbero entrarci qualcosa gli eruditi come il cardinale Cesare Baronio, autore originale del motto “la Sacra Scrittura insegna come si vadìa al cielo e non come vadìa il cielo“. O come l’arcivescovo Alessandro Piccolomini, che più volte nel ‘500 aveva accusato l’aristotelismo di non fondarsi su “sensate esperienze“. O come il grande storico e scienziato Paolo Sarpi, frate dell’ordine dei Serviti, che in una fitta corrispondenza con Galileo gli aveva illustrato una teoria dell’universo meccanicistica ricavata dai frammenti di Democrito. O come i neopitagorici, soprattutto francescani, ai quali si doveva fin dal XIII secolo l’idea che la natura fosse leggibile “in caratteri geometrici“. O come i gesuiti del Collegio Romano, dai quali Galileo ottenne non solo critiche ma anche spunti e preziose intercessioni politiche. O come l’alchimista Bernardino Telesio, teorico dell’indagine sulla natura “secondo i principi della natura stessa“, che aveva goduto della protezione di tre papi uno dopo l’altro.
Certo, il processo a Galileo ci fu e, come tutti sappiamo, andò male. I rovesci nella guerra dei Trent’Anni a partire dal 1631, quando Gustavo Adolfo di Svezia era sceso in campo contro la Lega Cattolica, avevano ottenuto il doppio effetto di accrescere il terrore delle eresie e di far cadere in disgrazia i prelati spagnoli con i loro collaboratori, tra i quali Giovanni Ciampoli, che era il protettore di Galileo alla corte di Urbano VIII. Non poteva esistere momento più sfortunato per pubblicare il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo“.

È anche innegabile che la condanna di Galileo rimase un odioso precedente al quale gli inquisitori si ispirarono in seguito per frenare, almeno in una parte del mondo cattolico e almeno in alcuni periodi, l’avanzata della rivoluzione scientifica. “Almeno in una parte” e “almeno in alcuni periodi” è d’obbligo specificarlo, visto che i controesempi sono numerosi e celebri (a partire dalle scoperte di Redi e dell’Accademia del Cimento fatte in Toscana una trentina d’anni dopo).
Ma allora perché è ancora tanto diffusa la favoletta propagandistica di Galileo “faro di razionalità” in mezzo a un mare di tenebre e superstizione? Sulla carta, non c’è nulla di più razionale dell’ammettere che nessun grande intelletto cresce in un deserto, e che senza un contesto di ricerca vivace, finanziata generosamente almeno da alcune autorità, nessun genio è in grado di far progredire il sapere.
Come è possibile che questo argomento di buonsenso venga sistematicamente accantonato in favore di una leggenda puerile sullo scienziato buono che aveva tutta la chiesa cattiva schierata contro di lui?
Si possono fare mille ipotesi sui movimenti politici di rottura ai quali la versione fiabesca di Galileo ha fatto comodo di volta in volta: nel ‘700 i liberali infastiditi dai privilegi del clero, nell’800 i positivisti infatuati della superiorità tecnica dell’Occidente moderno sui popoli “barbari”, dalla metà del ‘900 i giovani alle prese con l’emancipazione sessuale, di tanto in tanto i comunisti (specie se dovevano affrontare partiti conservatori d’impronta cristiana). Nel 2000 si sono aggiunti i tecnocrati della data religion e i profeti del transumanesimo.
Ma queste convenienze occasionali ci dicono solo una parte della verità. L’altra parte, che è la più dolorosa, è che col tempo abbiamo ristretto il significato di “razionalità”, appiattendolo sulla sola razionalità naturalistica.
E dire che la prima grande scienza moderna che aveva rivoluzionato l’Europa era stata proprio la filologia, l’arte discreta e sottile degli umanisti, che cercavano il metodo migliore per ricostruire il senso autentico di una fonte storica e il contesto preciso nel quale era stata scritta.
La razionalità dei filologi, che è una razionalità del tatto e del gusto, è stata del tutto messa in ombra dalla razionalità dei naturalisti, così capace di impressionare la vista e l’udito con le sue meravigliose scoperte e le sue potenti invenzioni. Ma il fatto che sia passata di moda non la rende meno razionale.
E l’imbarazzo che suscitano certi apostoli delle scienze naturali, quando provano a parlare di storia e si ritrovano puntualmente a inanellare favole rozze e miti infantili non supportati da alcuna fonte, non rende di certo onore alla loro razionalità.

Insomma, chi preferisce il mito di Galileo alla storia vera di Galileo preferisce l’esaltazione fanatica di una sola sfumatura della razionalità piuttosto che l’accettazione laica di tutte. Non dovrebbe essere così.
È razionalità anche la consultazione onesta delle fonti. È razionalità anche la ricostruzione plausibile dei contesti in cui gli eventi sono accaduti. È razionalità anche evitare di ideologizzare la storia, non solo far rotolare palline su un piano inclinato per provare che l’accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo.
Ricordarselo potrebbe essere un inizio di terapia contro la crisi d’identità dalla quale l’Occidente sembra sempre più afflitto.