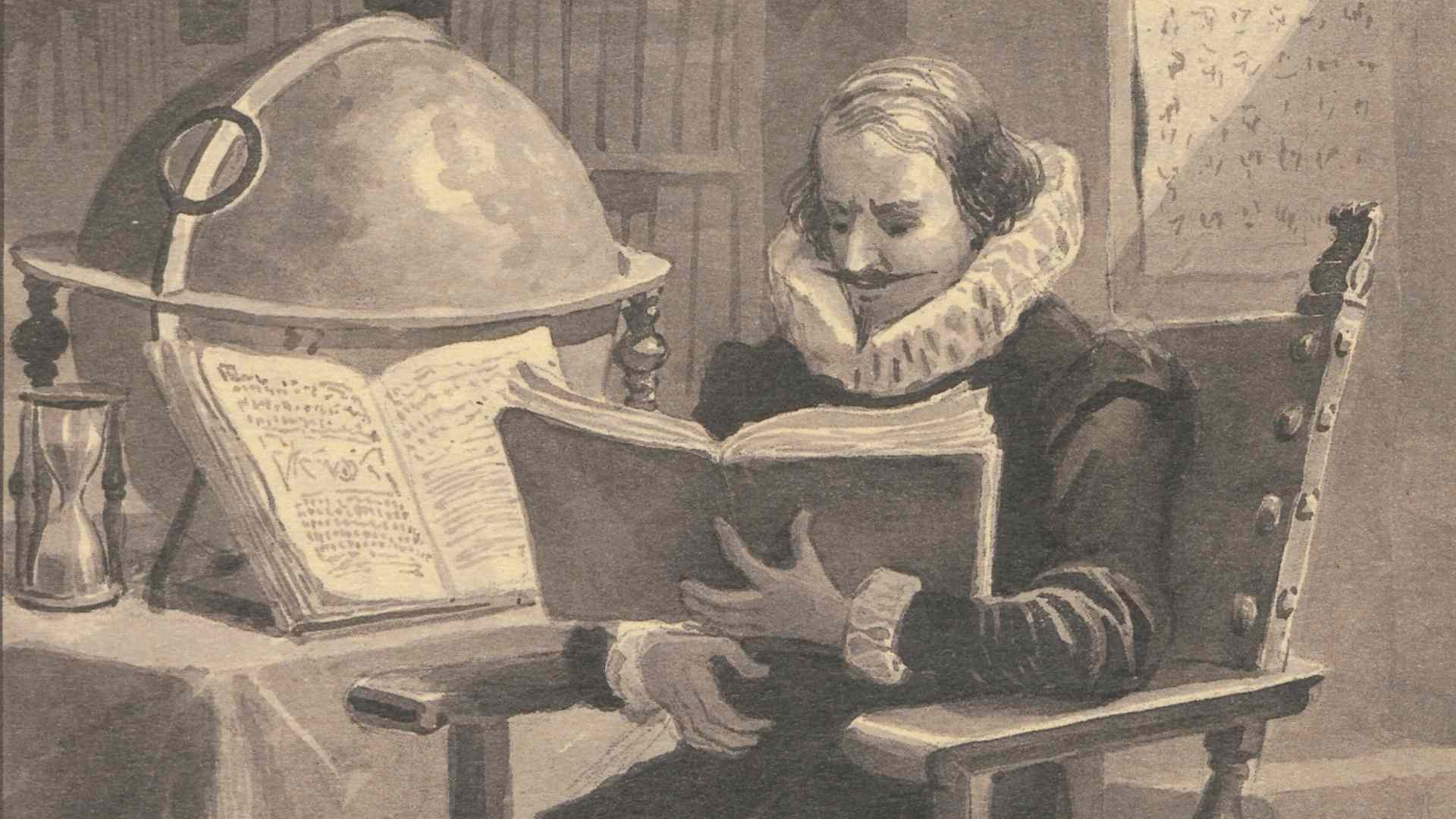Israele, l’Europa e un logoramento asimmetrico

A quasi due anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, l’equilibrio geopolitico in Medio Oriente si presenta come una riedizione aggiornata di scontri ideologici mai sopiti. Quello che a molti appariva come un conflitto in via di normalizzazione è improvvisamente regredito, riportando in superficie linee di faglia sepolte sotto decenni di diplomazia. Il seguente articolo analizza la natura dogmatica dell’attacco, i suoi obiettivi strategici, la reazione – non solo militare – di Israele e dell’Occidente e, infine, le implicazioni politiche dell’intervento dello Stato ebraico. Il tutto attraverso una lente che distingue la guerra reale dalla sua rappresentazione mediatica.
La guerra di principio: uno scenario per comprendere il futuro
Quasi due anni sono passati da quel tragico 7 ottobre 2023 che ha riavviato un conflitto in procinto di normalizzarsi. Qui un nostro approfondimento sulla storia del conflitto.
Il 7 ottobre non solo si caratterizza come attacco terroristico, ma come attuazione e revival della Risoluzione della Lega araba del 1967, passata alla storia come “I Tre No di Khartoum”.
Tale documento, recitava molto semplicemente la volontà di perseguire una linea internazionale di totale opposizione alla pace, ai rapporti diplomatici e alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Una questione di principio, come si suol dire, è pur sempre una questione di principio.
Per quanto tragiche, le guerre di principio sono particolarmente semplici da teorizzare e da classificare poiché gli elementi che portano al conflitto sono quasi esclusivamente fabbricati da assetti valoriali e dogmatici che rispettano linee semplici e prevedibili in misura maggiore rispetto a quanto richiesto per guerre più “naturali”. Motivo per cui, il foresight già proposto l’anno scorso, nonché il modello ivi contenuto, risulta ancora utile per comprendere quanto è accaduto e quali scenari potrebbero aprirsi in futuro.
Tale modello pone una relazione molto semplice individuando tre pilastri esistenziali in gioco – normalizzazione dei rapporti esterni, capacità di deterrenza e coesione interna – e ribalta gli obiettivi di Israele per definire i best/worst case.
Gli obiettivi di Hamas:
- Bloccare la normalizzazione con l’estero, esportando il conflitto.
- Forzare Israele in un trade-off tra deterrenza e coesione/relazioni esterne.
- Strumentalizzare le vittime civili per dividere le popolazioni arabe e israeliane, influenzando l’opinione pubblica islamica ed occidentale.
Conseguenze:
Israele, non volendo rinunciare alla deterrenza, subirà un calo di profondità strategica e di unità interna: potrà tentare di compensare aumentando la forza deterrente a livelli incontrollabili, con rischi per la democrazia.
Best case: conflitto circoscritto; Gaza reintegrata con soluzioni che vanno dall’assorbimento all’amministrazione condivisa.
Worst case: guerra regionale estesa fino a Teheran; overstretch militare; tensioni interne e nella NATO.
In entrambi i casi, si profila una rapida discesa dell’era Netanyahu, un ridisegno dell’assetto politico post-conflitto e un’accentuata polarizzazione occidentale.
Possiamo quindi sostenere nel 2025 che questo modello ha avuto per adesso conferma storica.
Il 7 ottobre 2023 Hamas ha obbligato il mondo ad imporre il proprio dogma. Tale dogma genocida, ornato da indumenti decorati di “resistenza” e “anticolonialismo” per essere venduti agli europei più sprovveduti, ha posto Israele in una condizione scomodissima: o rinuncia alla propria esistenza o rinuncia alla propria reputazione. Israele ha rinunciato a quest’ultima sotto gli occhi di un mondo che si è fatto allegramente beffare dalle forme più ridicole di propaganda.
L’inversione tra aggressore e aggredito: il capolavoro comunicativo di Hamas
Parlando squisitamente in termini tecnici, Hamas è riuscita in un imponente gioco di prestigio, cancellando dalla memoria collettiva sia accademica che popolare alcuni criteri universali necessari per comprendere qualsiasi conflitto.
Intanto, sembra che l’Occidente intero e in primis la nostra Europa abbia dimenticato la prima legge della guerra: non ci si è chiesti chi abbia commesso il crimine di aggressione.
Altra verità scomparsa dai radar sotto un silenzio assordante: il numero dei morti in guerra non è verificabile. In nessuna guerra, antica o contemporanea è stato possibile determinare il numero dei morti neanche a distanza di anni.
Anagraficamente, in condizioni di pace, è più semplice definire chi è presente, ma non chi non è presente. Se rintracciare i deceduti è complesso anche in periodo di pace, durante la guerra di grandi dimensioni è impossibile. Questa è una verità che si applica a qualsiasi guerra e si è sempre applicata. Basta guardare ai numeri relativi alle vittime della seconda guerra mondiale, il conflitto su cui si è dibattuto di più in assoluto: si troveranno solo ed esclusivamente stime.
Dal 7 ottobre 2023 in poi invece, il gruppo terroristico palestinese sembra aver sovvertito questa regola generale, forse aiutato da una a noi sconosciuta tecnologia aliena tale per cui si rende per loro possibile contare con assoluta certezza e precisione il numero delle vittime, conoscere se fossero combattenti o meno, e riuscire ad annunciarlo in diretta TV nel momento stesso del decesso. Qualcosa di mai visto prima, una sorprendente capacità di calcolo in tempo reale, accettata senza verifica da organi internazionali e media occidentali e ciò dovrebbe fare riflettere: se un gruppo terroristico, parte scatenante del conflitto e avente una mistica tecnologia sconosciuta a tutti che riesce a fornire numeri così precisi in diretta televisiva, riesce a spacciare come verità assoluta la propria propaganda, forse il problema non è Hamas, forse il problema siamo noi.
Poiché infatti, se l’obiettivo di Hamas è Israele, il proiettile è l’opinione pubblica europea: tutto il comportamento strategico e tattico di Hamas si basa sullo scagliare gli alleati di Israele contro Israele stesso nel tentativo di fare implodere il suo cerchio di relazioni diplomatiche. Ma, se noi europei siamo il proiettile dell’arma palestinese, ovviamente qualche contraccolpo lo subiamo anche noi.
Questo dato inequivocabile deve farci interrogare sulla struttura, la tenuta e la salubrità delle nostre democrazie che in quanto tali trovano il proprio fondamento nel come vengono gestite le informazioni dalla quale si dirama, appunto, l’opinione pubblica. Con una sempre maggiore crescita di radicalizzazione giovanile e universitaria, una disconnessione tra politica e opinione pubblica e una frattura dell’autorità discorsiva: i concetti di “pace”, “giustizia” e “diritti” sono ormai fluidificati e manipolabili.
Il margine politico e la fine dell’asimmetria a senso unico
Il conflitto in corso tra Israele e Hamas rappresenta molto più di uno scontro armato. È, piuttosto, una crisi strutturale che mette a nudo i limiti della proiezione di potere in un contesto saturo di vincoli interni ed esterni, dove ogni scelta genera un contraccolpo. Non siamo di fronte a una guerra “da vincere” secondo logore logiche novecentesche. Siamo davanti a una sequenza di riconfigurazioni strategiche in cui l’obiettivo non è mai la vittoria assoluta, bensì la sopravvivenza del margine politico.
In questo quadro, Israele appare stretto in una trappola costruita nel tempo: ogni tentativo di ristabilire la deterrenza militare comporta un prezzo crescente in termini di legittimità democratica e capitale diplomatico. Si tratta di un trade-off sistemico che indebolisce la capacità dello Stato ebraico di presentarsi come attore razionale, credibile e centralizzato nel panorama internazionale.
Da un lato, la necessità di rispondere con forza agli attacchi terroristici; dall’altro, la crescente difficoltà nel contenere le conseguenze politiche, interne ed esterne, di ogni operazione militare.
Hamas non ha la forza di sconfiggere Israele militarmente. Ma ha imparato a strutturare il conflitto in modo tale da obbligare Tel Aviv a reagire in forme che indeboliscono la sua posizione politica e diplomatica. È questo il vero punto di svolta: Hamas combatte sul piano della comunicazione e della psicologia collettiva. Costringe Israele a muoversi nel perimetro del trauma, a rinnovare la narrativa dell’eccezionalismo della propria sicurezza, e allo stesso tempo contribuisce a delegittimare l’immagine internazionale dello Stato israeliano, soprattutto presso le nuove generazioni in Occidente.
Il problema, però, non si esaurisce nella dimensione comunicativa. Il conflitto in corso aggrava una crisi di leadership interna che il governo Netanyahu non è più in grado di contenere. L’unità politica si regge su coalizioni fragili, su un’opinione pubblica divisa, e su istituzioni sempre più polarizzate. La società israeliana sta affrontando una frattura generazionale e culturale profonda tra chi chiede sicurezza assoluta e chi inizia a interrogarsi sulla sostenibilità morale e strategica dell’attuale approccio.
Questa mancanza di coesione interna si riflette anche nella gestione delle alleanze. Se un tempo Israele rappresentava l’avamposto dell’Occidente in Medio Oriente, oggi quella narrazione è indebolita dalla progressiva disaffezione di parte delle opinioni pubbliche occidentali. L’inerzia diplomatica, la gestione opaca delle operazioni a Gaza, e l’incapacità di proporre un piano politico credibile per il post-conflitto stanno erodendo il soft power israeliano.
Israele si muove oggi in un campo minato dove ogni gesto è una prova di forza che diventa, però, una dimostrazione di vulnerabilità. È la fine dell’asimmetria a senso unico. Hamas non può vincere, ma può logorare. Israele può colpire, ma perde sempre qualcosa in termini di reputazione, sostegno o legittimità.
La vera sfida per Tel Aviv, insomma, non è più semplicemente e puramente militare bensì è politica: serve una nuova narrazione, capace di ripensare le priorità strategiche del Paese e che sappia parlare in un mondo che non accetta più la logica binaria tra sicurezza e diritto.
Il grande assente: l’Europa
L’Unione Europea osserva, reagisce a fatica, si divide. L’asse franco-tedesco è fragile, l’Italia ondeggia tra istinto atlantista e calcolo geopolitico, i Paesi dell’Est si allineano agli USA, mentre l’opinione pubblica europea vira sensibilmente verso una posizione critica nei confronti di Israele.
La frattura è evidente e pericolosa. Perché mentre la politica cerca di mantenere una neutralità che non regge più: le piazze si radicalizzano, le università protestano, i giornali oscillano e il consenso per la causa palestinese aumenta, anche dove un tempo era marginale.
Questa distanza crescente tra le istituzioni europee e i propri cittadini sulla questione israelo-palestinese è un campanello d’allarme politico. L’Europa si ritrova in una posizione di irrilevanza strategica, incapace di esercitare una funzione di mediazione o proposta. La retorica dei due Stati è diventata un mantra privo di strumenti concreti. E mentre l’America usa i dazi come strumenti negoziali, l’Unione Europea resta bloccata tra le dichiarazioni di principio e la realtà della sua impotenza geopolitica.
Israele, dal canto suo, sembra poco interessato a coltivare il consenso europeo. La dottrina Netanyahu, e in generale la postura di governo israeliana negli ultimi anni, ha progressivamente spostato il baricentro verso un’alleanza funzionale e ideologica con Washington, anche a costo di sacrificare i ponti con Bruxelles. In questo senso, il conflitto diventa una linea di frattura definitiva tra chi comanda con la forza e chi difende la forma.
La strategia europea per non soccombere: difendere la forma
La forma – fatta di diritto internazionale e norme condivise – è l’unico spazio dove l’Europa può ancora esercitare influenza. Se questo viene svuotato, resta poco altro. L’Unione si ritroverà spettatrice passiva di un conflitto che alimenta tensioni interne, polarizzazioni sociali, e la crisi dello stesso ordine liberale che dice di voler difendere.
Israele combatte per la sua sicurezza, ma rischia di compromettere la sua collocazione morale.
L’Europa osserva, ma rischia di scomparire come attore politico rilevante.
La sfida, allora, non è solo di natura militare. È una sfida alla narrazione, alla rappresentazione, al significato stesso di cosa sia oggi “l’Occidente” in un mondo che si riscopre multipolare, fragile e in conflitto permanente.
In questo equilibrio instabile, chi saprà proporre una nuova visione della coesistenza, del diritto e della sicurezza, non solo sopravvivrà. Comanderà.