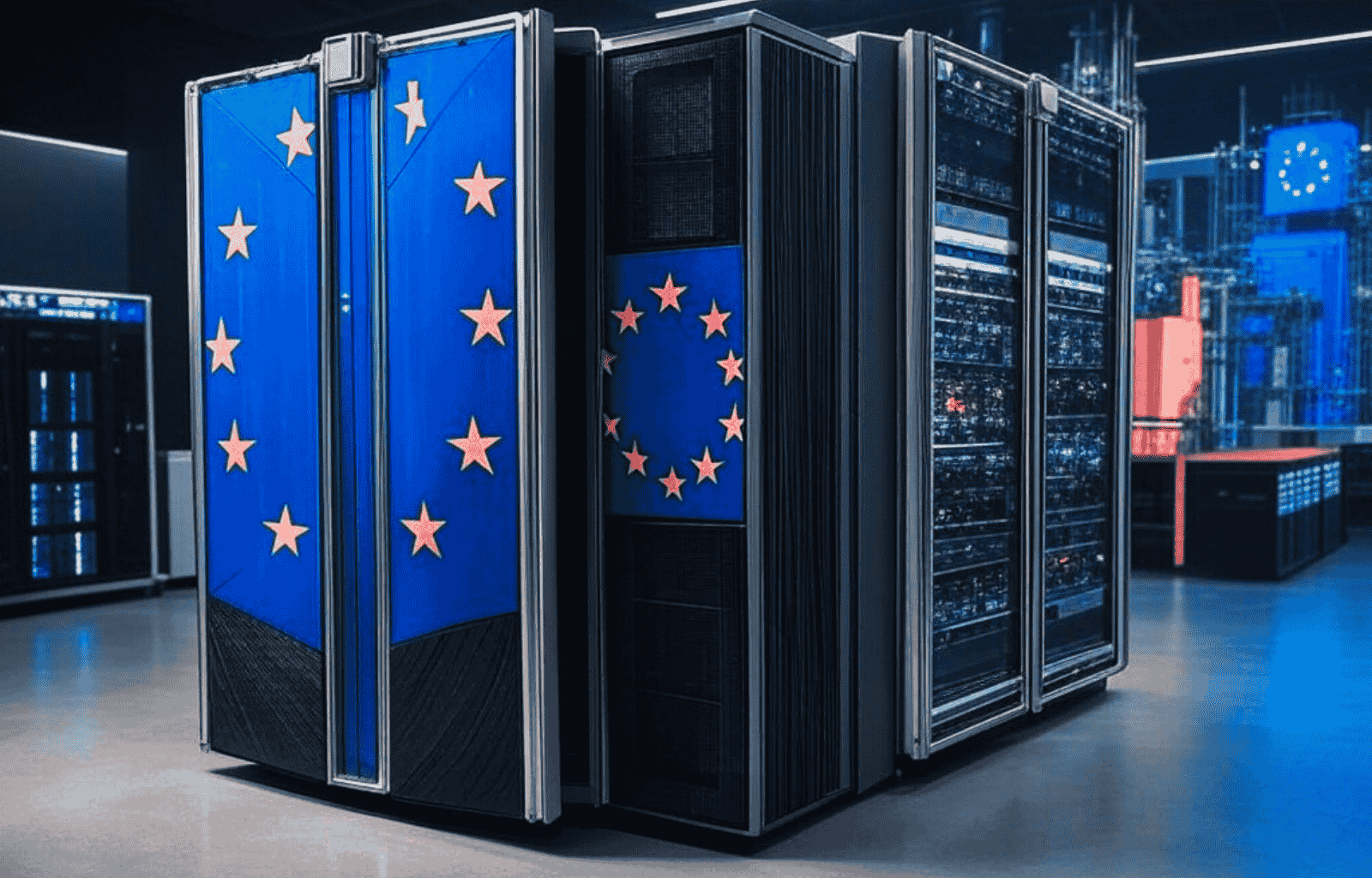La crisi di Beko Italia, simbolo del collasso

Il 10 dicembre l’ISTAT ha divulgato i dati sulla produzione industriale italiana di ottobre, che registra un calo del 3,6% su base annua, gravato dallo sprofondare dei settori dell’automotive (-40%) e dell’abbigliamento. Con ottobre, il Paese giunge così al ventunesimo mese consecutivo di riduzione dell’indice in questione, ormai ai minimi dall’inizio della pandemia; dato ancora più sconfortante se confrontato con i livelli del 2021, anno rispetto al quale il calo raggiunge il -5,5%, nonostante all’epoca fossero ancora in vigore notevoli restrizioni da imputare all’emergenza sanitaria.
Nello stesso giorno, presso il Mimit, il Ministro Urso riceveva i vertici di Beko Italia – azienda il cui fallimento appare ormai ineludibile – i quali confermavano l’imminente licenziamento di 1.935 dipendenti, pari a una riduzione del 44% della forza lavoro impiegata dal marchio nei suoi stabilimenti italiani, destinati anch’essi a una chiusura ormai prossima.
La crisi – non solo della filiale italiana, ma di molti branch europei – della multinazionale turca dell’elettrodomestico ha ragioni che ben si prestano a interpretare i numeri della congiuntura particolarmente negativa che affligge tutte le principali economie comunitarie: il costo dell’energia, il rallentamento della supply chain, il conflitto russo-ucraino ma, su tutte, la difficoltà di mantenere la produzione di molte categorie di beni entro i confini europei per via dei costi – soprattutto della manodopera – che impediscono di affermarsi sulla concorrenza asiatica, traducendosi in margini ridotti per le imprese e prezzi più elevati che i consumatori non sono disposti a pagare, con conseguente crollo delle quote di mercato.
Con il Pil, la produzione industriale e il tasso di occupazione in contrazione persino in Germania – locomotiva d’Europa ormai inceppata – appare sempre più urgente un approccio radicalmente diverso a quell’inesorabile e irreversibile fenomeno che è la delocalizzazione della produzione industriale. Di fatti, come amava sostenere il premio Nobel per l’economia Milton Friedman, i contribuenti “votano con i piedi”; le imprese, nondimeno, mosse come sono da logiche razionali, si spostano dove più conviene. Non vi è nulla, nei mercati globali, che gli Stati possano fare per arrestare l’emorragia di un’economia – la nostra – destinata a diventare post-industriale.

In siffatto scenario appaiono risibili i tentativi di ricorrere a logiche dal retaggio novecentesco quali il golden power paventato, appunto, da Urso nel tavolo di confronto con Beko e le rappresentanze sindacali, in cui il Ministro ha preteso che i vertici dell’azienda formulino entro gennaio un piano industriale compatibile con le prescrizioni dello strumento normativo – pena la comminazione di sanzioni e la paventata facoltà di invalidare l’acquisizione, avvenuta in primavera, della Whirpool e dei suoi stabilimenti italiani da parte della multinazionale turca, con il paradossale ricorso a un dispositivo atto a tutelare settori di rilevanza strategica nazionale, tra i quali appare improbabile che possa rientrare la produzione di piani cottura, forni elettrici e congelatori.
Misure così drastiche – posto che siano realmente applicabili – per procrastinare l’inevitabile destino di un’azienda che non ha più ragione di esistere sortirebbero il solo effetto di dissuadere ulteriormente le imprese straniere dall’investire in un’Italia già tristemente nota per i suoi quadri fiscale, burocratico, normativo e legislativo instabili e ostici al business; timore, questo, che trova conferma nella sonora flessione degli investimenti diretti esteri nello Stivale, scesi del 12% su base annua nel 2023, e nella posizione tutt’altro che lusinghiera che l’Italia occupa nel Global Business Complexity Index 2024, dove si piazza terza tra i Paesi europei in cui è più difficile fare impresa.
Posta la sua ineluttabilità, la delocalizzazione della produzione industriale diviene un dramma economico, occupazionale e sociale solo se, non prendendone atto, un Paese non si dimostra in grado di pianificare la riconversione di ampi settori non più proficui del tessuto produttivo verso l’economia dei servizi. Per chi, come nel caso scuola della Repubblica d’Irlanda, adotta politiche volte a rendere gli investimenti nel Paese il più vantaggiosi possibile per le aziende di settori come l’high-tech e i servizi finanziari, sostanzialmente immuni alla concorrenza fondata su manodopera e materie prime a costi stracciati, la delocalizzazione rappresenta un’enorme opportunità di crescita, con nuove imprese pronte a investire e offrire più posti di lavoro, più qualificati e meglio retribuiti rispetto a quelli che, non a caso, sono migrati verso economie meno sviluppate.
In un tessuto produttivo che diviene competitivo in settori fortemente specializzati e ad alto valore aggiunto, il tasso di disoccupazione tende a rimanere particolarmente basso, e i nuovi posti di lavoro, che rimpiazzano i vecchi, riescono non solo ad assorbire e a reimpiegare, ma persino a migliorare le condizioni delle categorie esuberate dal sistema produttivo ormai superato.
Nel già citato Global Business Complexity Index 2024, l’Irlanda risulta saldamente tra i Paesi esaminati in cui è più vantaggioso fare impresa. Parimenti, nell’Indice della Libertà Economica 2024 stilato dalla Heritage Foundation, la “tigre celtica” occupa il terzo posto, prima per distacco tra i Paesi membri dell’UE e dietro soltanto a Singapore e Svizzera. L’indice in questione tiene conto di valori quali la libertà fiscale, imprenditoriale, finanziaria e del mercato del lavoro, il livello delle spese governative in percentuale del Pil, i diritti di proprietà, il tasso di corruzione e, non da ultima, l’efficienza normativa – evidenziando come il rispetto della rule of law e la libertà economica siano direttamente correlati.
Ex fanalino di coda d’Europa, dopo decenni di profondi conflitti politici e paramilitari con il Nord e il Regno Unito, il Paese del trifoglio ha registrato, a partire dagli anni ‘80 dello scorso secolo, un boom economico senza eguali, con tassi di crescita anche superiori al 7% su base annua, le cui ragioni sono da rinvenire nelle policy adottate da Dublino al fine di attrarre quantità di investimenti esteri da record. Oggi, grazie a un ambiente fiscale e normativo estremamente favorevole, l’Irlanda ospita le sedi europee delle principali aziende mondiali dei settori dell’high-tech e del farmaceutico, quali Google, Apple, Meta, Microsoft, Pfizer, Johnson & Johnson e Amazon. Il risultato è un Pil nominale pro capite che si attesta al terzo posto nella classifica mondiale, con il prodotto interno lordo che nel 2025, si stima, crescerà del 3,4%, mentre gran parte del continente è già in recessione.
Per gli esuberati della Beko, così come per altre centinaia di migliaia di lavoratori italiani ed europei, si prospetta un Natale cupo, con un orizzonte in cui si scorgono solo cassa integrazione, solidarietà, licenziamenti ed estrema difficoltà a trovare nuovi e dignitosi impieghi. La politica, rifuggendo ogni responsabilità, ha gioco facile a biasimare e demonizzare imprese a cui non viene elargito alcun concreto incentivo alla permanenza sul suolo europeo – al punto da pretendere che quelle stesse aziende stilino un piano industriale per il Paese al posto della classe dirigente che non è in grado di formularlo, soggiogata com’è da un orizzonte temporale miope poiché scandito unicamente dalla propria rielezione.