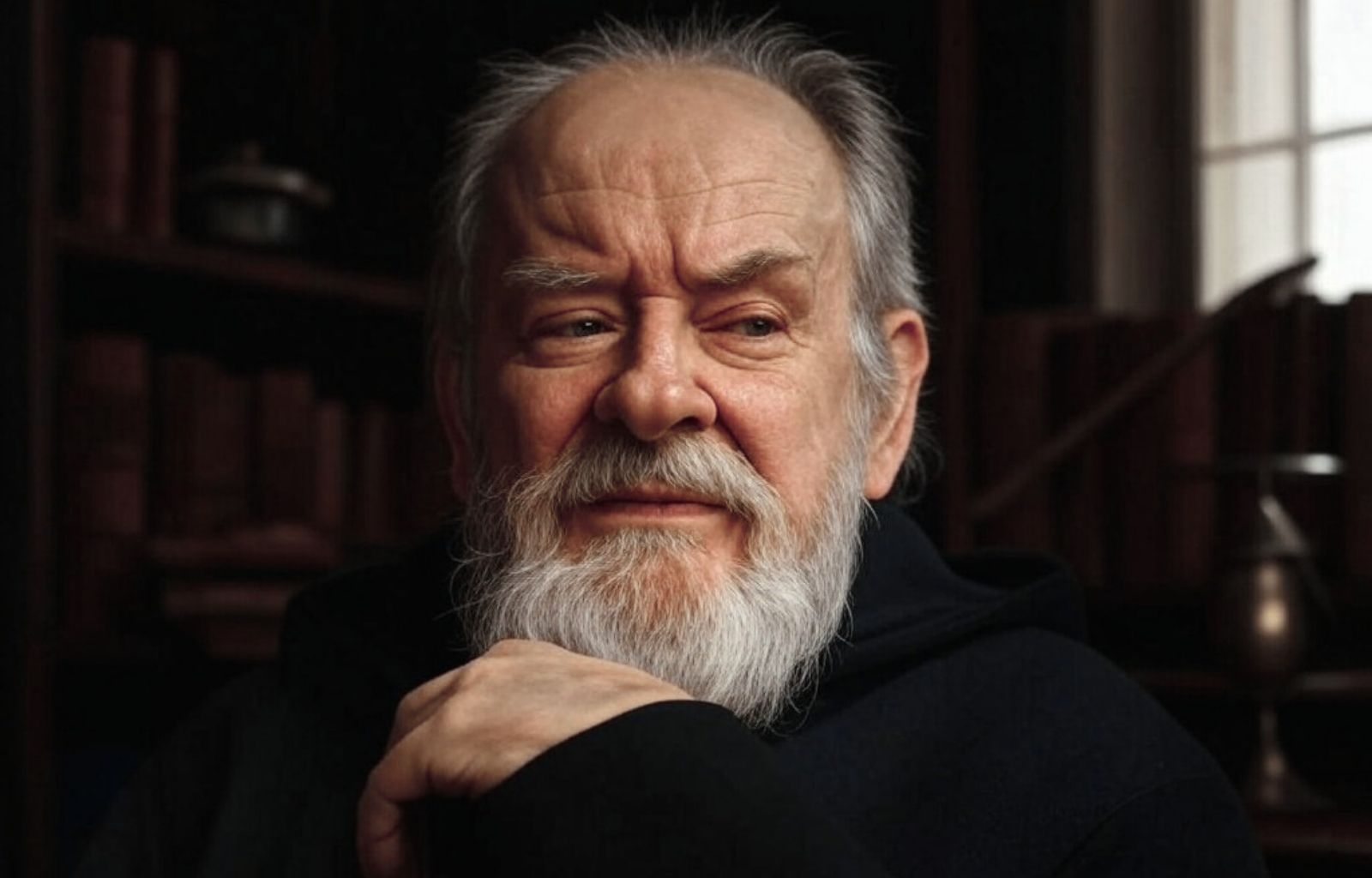L’Europa sul Baltico, il confine storico tra libertà e oppressione

L’estate scorsa ho fatto un viaggio nel Baltico con mia moglie. Quel mare freddo, poco profondo e poco salato, che recentemente è diventato campo di battaglia per la guerra ibrida russa, bagna un territorio ricco di tradizioni e di storia. Storia dai contorni spesso tragici, come d’altronde quella di tutta l’Europa.
Durante la Seconda guerra mondiale i nazisti sterminarono la popolazione ebraica di Vilnius, che era chiamata la Gerusalemme del Nord. Sul suo mare ghiacciato nel 1921 Trotskij stroncò la ribellione dei marinai della fortezza di Kronstadt, che lui stesso aveva definito “onore e gloria della rivoluzione” quattro anni prima.
Agli inizi del Settecento il Baltico fu teatro della Grande Guerra del Nord tra Russia e Svezia. Sempre in quelle zone, tra il XII e il XIII secolo i cavalieri dell’Ordine Teutonico (diventato poi Ducato di Prussia) e i suoi alleati condussero le Crociate del Nord.
Una Storia densa di avvenimenti e di sangue.
Dalla Finlandia a Tallinn, poi a Riga, infine a Vilnius, abbiamo incontrato ovunque, dalla stazione centrale di Helsinki al bar frequentato da studenti estoni, al palazzo presidenziale lituano, la bandiera ucraina. A Tallin l’ambasciata russa era circondata da bandiere giallo-azzurre e cartelli contro la guerra di Putin, paragonato ai nazisti (mentre in Italia per molta, troppa gente, il nazista sarebbe Zelenskj).
Oltre alla bandiera ucraina, nei tre paesi baltici abbiamo trovato dappertutto bandiere dell’Unione Europea e della NATO: per loro essere nella UE è un grande vantaggio. L’uso intelligente dei fondi europei (diversamente da quanto accaduto in Italia) ha permesso una straordinaria crescita economica e sociale. Quanto alla NATO, per questi paesi essa rappresenta una sicurezza (sebbene le certezze si siano affievolite con il Trump 2): l’alleanza atlantica è il deterrente che impedisce che le truppe russe si trovino nuovamente, per la quarta volta in poco più di un secolo, nelle loro terre.
A Riga, capitale della Lettonia, dopo una tappa necessaria nel quartiere Jugendstil con i palazzi costruiti dal padre di Sergej Eisenstein (quello della Corazzata Potёmkin, che non era una cagata pazzesca), siamo tornati nel centro storico e abbiamo visitato il Museo dell’Occupazione della Lettonia. Aperto nel 1993, si trova in una piazza che ospita ancora un monumento di epoca sovietica. Il museo gestisce anche la sede del KGB, in un altro edificio. Uno degli scopi del museo è “mostrare quello che è successo in Lettonia, alla sua terra e al suo popolo, sotto l’occupazione di due regimi totalitari (quello sovietico e quello nazista) dal 1940 al 1991”.
Nel museo sono presenti documenti di ogni genere che partono dall’indipendenza della Lettonia dopo il crollo dell’impero zarista. Si passa alla guerra di indipendenza vittoriosa contro i sovietici, quando Lenin cerca di riprendere il controllo di quei territori, tentativo riuscito in Ucraina ma fallito, oltre che nei paesi baltici, anche in Finlandia.
Poi nel 1939 arriva il patto Ribbentrop – Molotov e improvvisamente Hitler e Stalin diventano alleati. Si spartiscono la Polonia e stabiliscono le aree di influenza nell’Europa orientale. Da Hitler, quindi, il via libera per l’URSS per riprendersi Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia. Con i paesi baltici Stalin riesce là dove Lenin aveva fallito, ma ancora una volta la Finlandia non cede. La breve ma cruentissima Guerra d’inverno, combattuta praticamente al buio e in mezzo alla neve e al ghiaccio, in cui i russi schierano 100 volte il numero di tank in dotazione ai finlandesi, è un bagno di sangue per i sovietici, che in totale hanno 400 mila soldati morti, feriti o dispersi. Alla fine Stalin si accontenta di una grossa porzione della Carelia, di un paio di isole e dello sbocco finlandese nel Mare Artico. La Finlandia perde il 10% del territorio ma protegge la sua libertà, per diventare una delle nazioni più democratiche e con uno dei migliori welfare del mondo. In seguito i finlandesi combattono ancora contro i russi e poi anche contro i nazisti tedeschi, in Lapponia. La memoria di queste vicende ha determinato la decisione di non abolire il servizio militare obbligatorio, mantenendo un esercito ben addestrato e una riserva di quasi un milione di effettivi. Oltre il 70% dei finlandesi si dichiara pronto a combattere in caso di invasione.
La Lettonia, invece, torna sotto il giogo russo, interrotto dall’invasione nazista quando Hitler rompe il patto nazi-sovietico, per ritornare poi ai sovietici nel 1944. Un lettone su dieci viene deportato in Siberia, con motivazioni varie. Bambini compresi. Stessa sorte subiscono Lituania ed Estonia, compresa la famiglia dell’ex premier estone Kaja Kallas, oggi Alta Rappresentante UE per la politica estera.
I tre paesi baltici devono aspettare il crollo dell’URSS per ottenere l’indipendenza. Ma si danno da fare per accelerare il processo, con scioperi e manifestazioni e soprattutto con la catena umana che unì circa due milioni di persone, da Vilnius a Tallinn, il 23 agosto 1989, esattamente nel cinquantesimo anniversario del patto Ribbentrop – Molotov.
Spesso, tra i filorussi, si sente parlare di russofobia o di simpatie naziste degli abitanti dei paesi baltici, come d’altronde per gli ucraini. Ci sono sicuramente estremisti di destra, come nel resto d’Europa. Ma tutto sommato molti meno che in altre nazioni, dove spesso sono finanziati direttamente o indirettamente dal Cremlino, come ad esempio AfD. Ci sono alcune tensioni con le comunità russe. Ma certamente, nel Baltico, la diffidenza verso i russi è giustificata, dato che dal primo Zar (il principe di Moscovia Ivan IV nel XVI secolo) a oggi, a prescindere dal tipo di regime, la loro storia è una storia di invasioni .
La frontiera della UE a est è delicata. La lunga serie di sabotaggi nel Mar Baltico e gli attacchi hacker confermano i timori dei paesi che si trovano lungo questa frontiera e indicano a tutta l’Unione Europea che la Russia, e probabilmente in misura minore anche la Russia e la Cina non sono nazioni amiche ma fonte di pericolo.
Se in Italia abbiamo visto bruciare bandiere UE, nel Baltico le stesse bandiere sventolano e sono portate con orgoglio.